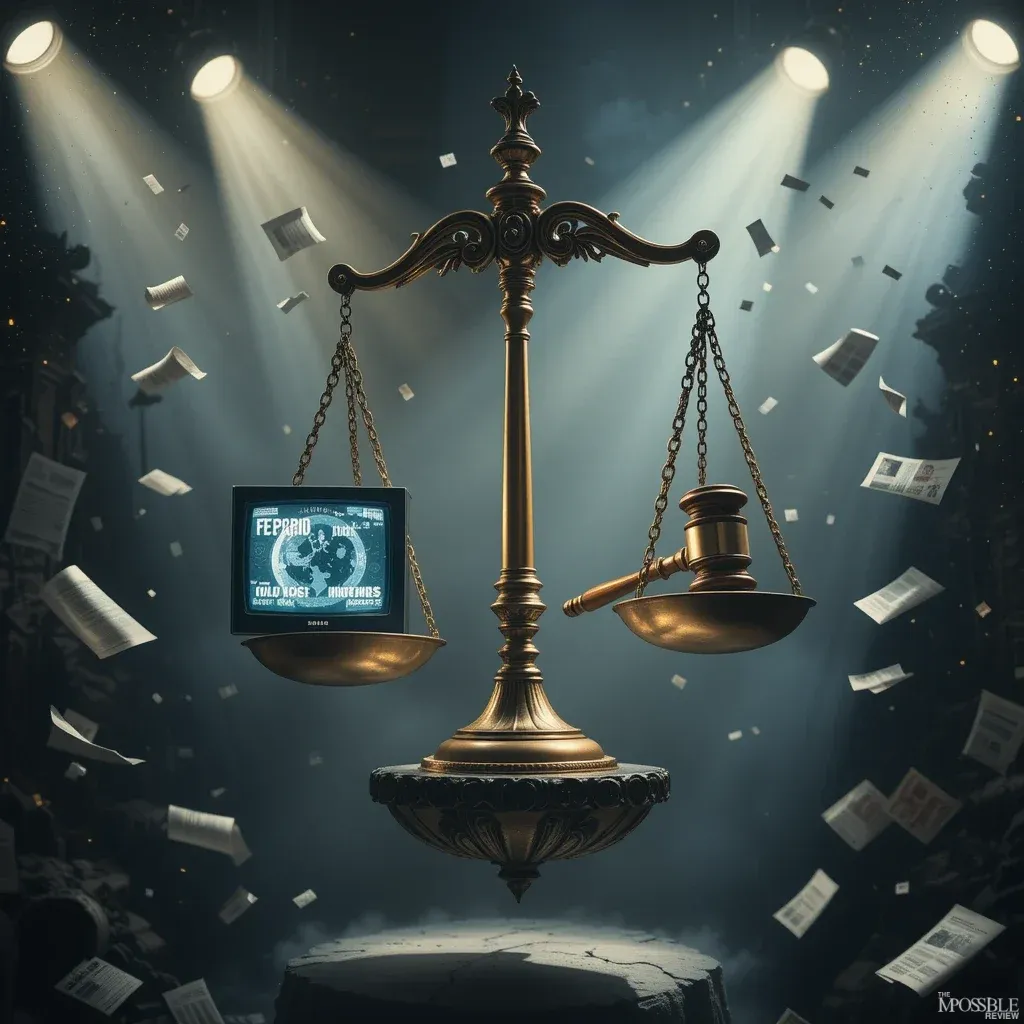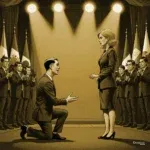Il tema che si pone riguarda il ruolo dell’Europa nell’attuale scenario geopolitico in trasformazione, con particolare attenzione alle sfide che emergono dal possibile indebolimento delle relazioni transatlantiche, e alle risorse di soft power e tradizione giuridica su cui l’Europa può contare. Abbiamo deciso di intervistare Hannah Arendt, filosofa politica che ha vissuto sulla propria pelle la fragilità della democrazia europea, l’ascesa dei totalitarismi e il successivo rifugio negli Stati Uniti. La sua riflessione sul potere, sull’autorità, sulla responsabilità politica e sul destino della cultura europea la rende una voce particolarmente acuta per riflettere sulle attuali sfide geopolitiche dell’Europa e sul suo patrimonio di valori.
Professoressa Arendt, l’Europa si trova ad affrontare un periodo di sconvolgimenti geopolitici in cui il rapporto privilegiato con gli USA sembra indebolirsi. Come vede questa situazione?
Quello che sta accadendo non è semplicemente un cambiamento nelle relazioni diplomatiche, ma un momento di verità per l’Europa. La crisi rivela sempre ciò che altrimenti rimarrebbe nascosto. Il rapporto transatlantico, dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha permesso all’Europa di ricostruirsi sotto una protezione che la dispensava, in un certo senso, dal pieno esercizio della propria responsabilità politica. Questa condizione ha consentito una straordinaria pacificazione interna, ma ha anche indotto una sorta di immaturità politica.
L’Europa si è abituata a delegare gran parte delle questioni di sicurezza esterna. Ora, il possibile indebolimento di questo legame non va visto solo come una minaccia, ma come l’occasione per un risveglio della coscienza politica europea. “Il potere si attualizza solo dove parole e azioni si sostengono a vicenda”, come scrissi in “Vita Activa”. È tempo che l’Europa trovi le parole e le azioni appropriate alla propria realtà.
Alla luce delle recenti decisioni dell’amministrazione Trump sulla sospensione dell’appoggio militare all’Ucraina e della proposta “Rearm Europe” della Commissione von der Leyen, come vede evolversi la relazione transatlantica?
Ciò che stiamo osservando è un punto di svolta che obbliga l’Europa a confrontarsi con la propria condizione politica reale. La protezione americana, che per decenni ha permesso all’Europa di vivere in una sorta di “minorità politica”, quell’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro, come direbbe Kant, si sta rivelando per quello che è sempre stata: un rapporto contingente, non un dato naturale.
La proposta “Rearm Europe” rivela una verità che l’Europa ha cercato di eludere: la sicurezza ha un costo che qualcuno deve pagare. Ma attenzione: il riarmo, di per sé, non costituisce una politica. La domanda fondamentale non è “quante armi possiamo produrre?”, ma “per quale progetto politico comune siamo disposti a impiegare la forza?”
Come ho scritto, “il potere sorge tra gli uomini quando agiscono assieme, e svanisce quando si disperdono”. La vera domanda per l’Europa oggi è se saprà agire assieme di fronte a queste sfide, o se si disperderà in reazioni frammentate. Il piano “Rearm Europe”, se vuole essere più di un semplice slogan, dovrà articolare non solo una strategia di difesa, ma una visione politica che risponda alla domanda: quale spazio pubblico europeo stiamo cercando di proteggere?
Si parla molto del soft power europeo come risorsa in questo frangente storico. È d’accordo con questa valutazione?
Il soft power è certamente una risorsa importante, ma dobbiamo essere chiari su cosa intendiamo. Se per soft power intendiamo solo l’attrattiva del modello di consumo europeo o la forza delle sue industrie culturali, allora stiamo parlando di qualcosa di transitorio e superficiale. Il vero contributo dell’Europa risiede altrove, nella sua esperienza unica di aver trasformato secoli di conflitti interni in un sistema di coesistenza basato sul diritto e sul riconoscimento reciproco delle differenze.
Ricordiamoci che l’Europa è nata dalla pluralità – non solo una pluralità di nazioni, ma di lingue, tradizioni, concezioni della vita. Questa pluralità è stata spesso fonte di conflitti tragici, ma ha anche insegnato all’Europa che l’ordine politico deve emergere dal riconoscimento della diversità, non dalla sua soppressione. Il soft power europeo, se ha un significato profondo, risiede in questa capacità di creare spazi pubblici in cui le differenze possono manifestarsi senza distruggersi a vicenda.
Lei menziona il diritto come uno dei pilastri dell’identità europea. In che modo questa tradizione giuridica può essere un punto di forza in un mondo sempre più caratterizzato da rapporti di forza?
Il diritto europeo non è semplicemente un insieme di norme, ma il risultato di un lungo apprendimento storico. L’Europa ha compreso, attraverso esperienze dolorose, che il diritto è ciò che protegge lo spazio della politica dalla violenza pura. Il diritto, come lo intendo, è la condizione preliminare per quello che chiamo “il mondo comune” – lo spazio in cui gli uomini possono apparire gli uni agli altri come esseri politici, capaci di azione e discorso.
Nell’Europa moderna, il diritto ha assunto il compito di strutturare relazioni pacifiche tra entità che conservano la loro diversità. È un’alternativa all’impero, che impone uniformità, e al nazionalismo esclusivo, che nega l’interdipendenza. Questa concezione del diritto come struttura di una pluralità pacifica è forse il contributo più prezioso che l’Europa possa offrire a un mondo che oscilla pericolosamente tra frammentazione e omologazione.
Ma attenzione: il diritto senza potere diventa sterile, così come il potere senza diritto diventa tirannico. L’Europa deve trovare le forme appropriate di potere per sostenere la sua visione giuridica.
Considerando le tensioni con la Russia, la crescente assertività della Cina e l’incertezza delle relazioni con gli USA, quali risorse interiori dovrebbe mobilitare l’Europa?
L’Europa possiede una risorsa fondamentale che spesso dimentica: la sua esperienza di catastrofi e rinascite. Ha sperimentato il totalitarismo e ha compreso che le fondamenta della vita politica possono crollare. Questa consapevolezza, sebbene dolorosa, è una forma di saggezza politica. L’Europa sa che la libertà non è garantita e che le istituzioni devono essere continuamente rinnovate attraverso l’azione concertata dei cittadini.
Ciò che l’Europa deve recuperare è il coraggio di pensare in modo originale la propria posizione nel mondo. Non è né una superpotenza né un museo. È piuttosto un laboratorio politico unico, in cui l’antica questione di come organizzare la vita comune tra diversi viene continuamente rielaborata.
Il pericolo è che l’Europa si lasci sedurre dalle narrazioni della necessità – l’idea che esistano solo determinate risposte possibili alle sfide geopolitiche. Ma la politica autentica inizia proprio dove la necessità finisce, nello spazio della libertà umana. L’Europa deve ritrovare la fiducia nella propria capacità di iniziare qualcosa di nuovo.
In un contesto in cui si parla di autonomia strategica europea, quale significato attribuirebbe a questo concetto?
L’autonomia non significa autarchia o isolamento. Significa piuttosto la capacità di agire secondo principi che emergono dalla propria esperienza e riflessione. L’autonomia europea non dovrebbe essere concepita in opposizione agli altri, ma come un contributo specifico a un mondo più plurale.
L’Europa ha imparato che l’assoluta sovranità nazionale è un’illusione che produce solo conflitti. Ha sviluppato forme di autorità condivisa che preservano l’identità delle parti mentre creano uno spazio comune di azione. Questa è una lezione politica di enorme valore in un mondo che cerca nuovi equilibri.
L’autonomia strategica europea, se ha un senso profondo, è la capacità di portare questa sapienza politica nelle relazioni globali – non imponendo un modello, ma dimostrando che è possibile una forma di ordine che non sacrifica la pluralità sull’altare dell’uniformità o dell’egemonia.
Un’ultima domanda: se dovesse indicare una direzione per l’Europa di oggi, quale sarebbe?
Direi all’Europa di non cedere alla tentazione della nostalgia né a quella del mimetismo. Non può tornare a un passato in cui le nazioni europee dominavano il mondo, né può semplicemente imitare altre potenze. La sua forza sta precisamente nella sua unicità storica.
L’Europa deve ricordare che la grandezza politica non consiste nel dominio, ma nella capacità di creare spazi in cui la libertà umana possa manifestarsi. La vera sfida è trovare le forme istituzionali e le pratiche politiche che permettano al pluralismo europeo di esprimersi come una forza creativa nel mondo, non come una debolezza da superare.
In un’epoca in cui le democrazie sono minacciate dall’interno e dall’esterno, l’Europa ha il compito di dimostrare che un ordine politico fondato sulla pluralità, sul diritto e sulla partecipazione può essere non solo giusto, ma anche resiliente. Come scrissi una volta, “la politica si basa sul dato di fatto della pluralità degli uomini”. L’Europa è il luogo dove questo principio ha trovato le sue espressioni più complesse. È tempo di riscoprire questa eredità non come un peso, ma come una promessa.
Glossario dei concetti chiave
- Pluralità: Concetto centrale nel pensiero arendtiano che indica la condizione umana dell’essere tutti uguali, cioè umani, e tutti diversi, cioè individui unici. La pluralità è la condizione per l’azione politica.
- Mondo comune: Lo spazio pubblico condiviso che si forma tra le persone attraverso l’azione e il discorso, permettendo l’apparizione della pluralità umana.
- Soft power: Capacità di influenzare il comportamento di altri attraverso mezzi culturali e ideologici piuttosto che coercitivi.
- Vita Activa: Termine usato da Arendt per indicare tre fondamentali attività umane: il lavoro, l’opera e l’azione. Solo l’azione è propriamente politica.
- Autonomia strategica: Capacità di un’entità politica di definire e perseguire i propri interessi e obiettivi strategici in modo indipendente.
- Spazio pubblico: Area dove i cittadini possono incontrarsi, discutere e agire politicamente. Per Arendt è essenziale per l’esistenza della libertà politica.
- Totalitarismo: Forma di dominio caratterizzata dalla cancellazione dello spazio pubblico e dall’eliminazione della pluralità umana in nome di un’ideologia totale.
Riferimenti bibliografici
- Arendt, H. (1958). Vita Activa. La condizione umana.
- Arendt, H. (1951). Le origini del totalitarismo.
- Arendt, H. (1970). Sulla violenza.