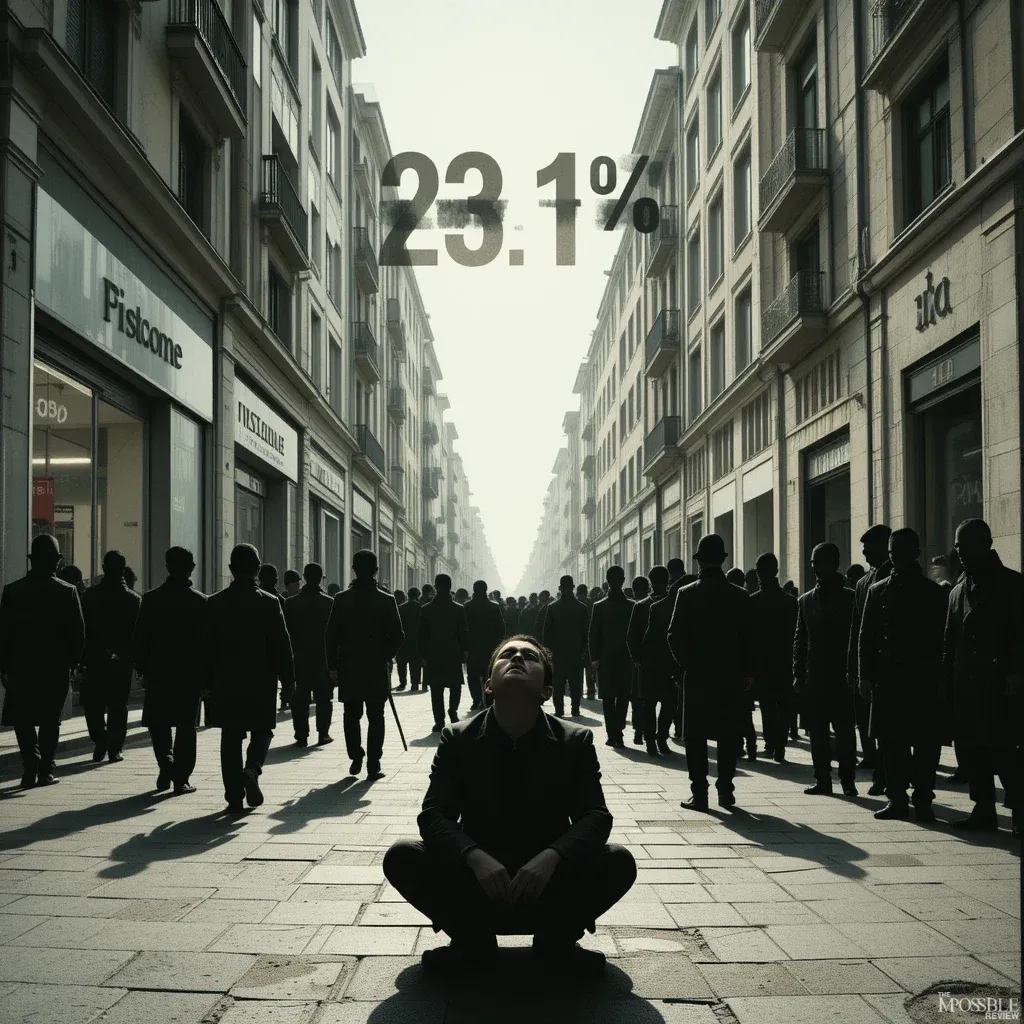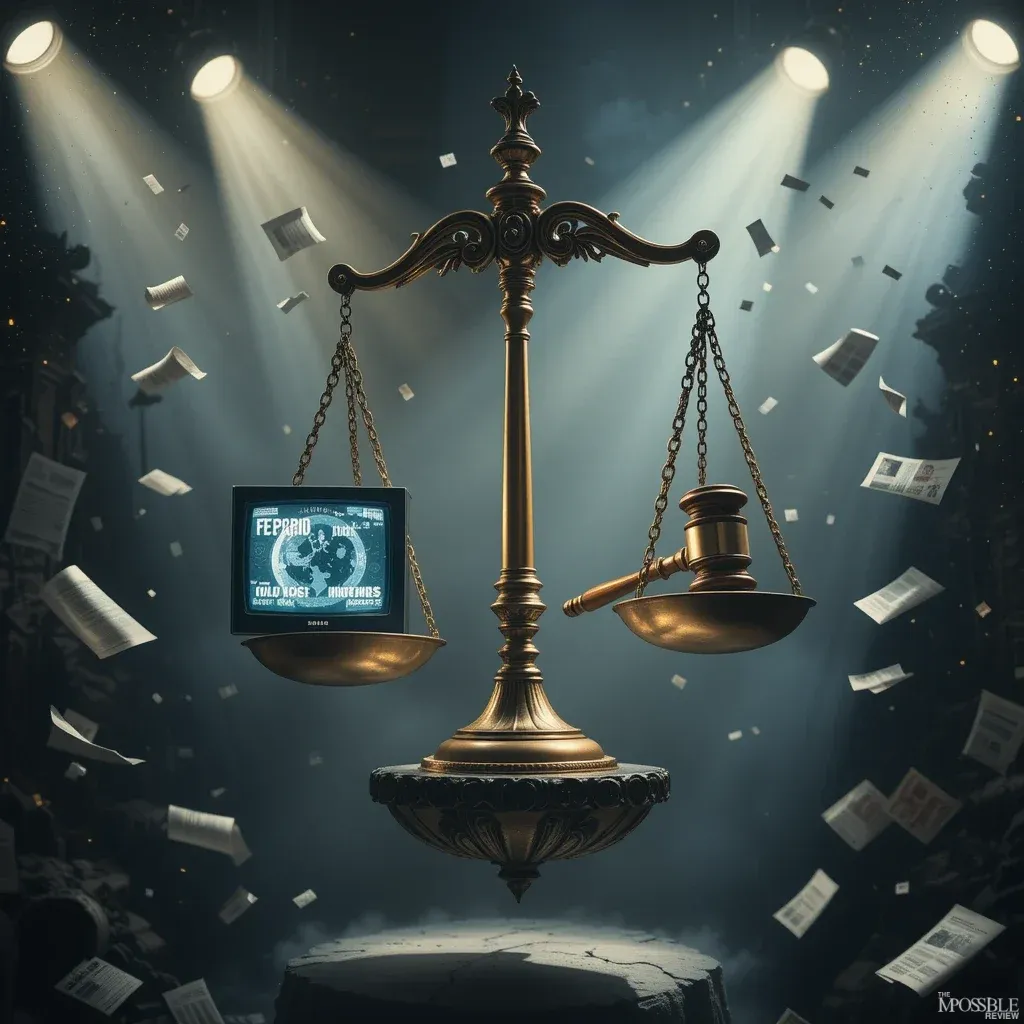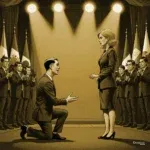Il recente rapporto ISTAT sulle Condizioni di vita e reddito delle famiglie per gli anni 2023-2024, pubblicato il 26 marzo, rivela un preoccupante panorama sociale italiano: il 23,1% della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale, con un incremento rispetto al 22,8% del 2023. I redditi familiari, nonostante l’aumento nominale del 4,2%, sono diminuiti dell’1,6% in termini reali a causa dell’inflazione.
Con una missiva impossibile abbiamo chiesto a Pier Paolo Pasolini di offrirci uno sguardo critico su questi dati, consapevoli che la sua voce profetica e la sua analisi impietosa della società dei consumi possano illuminare con straordinaria attualità le contraddizioni della nostra epoca.
Eccomi dunque a commentare cifre e statistiche, io che ho sempre preferito i volti, le rughe, i dialetti. Ma questi numeri dell’ISTAT parlano, gridano, denunciano. Il 23,1% degli italiani a rischio povertà o esclusione sociale. Tredici milioni e mezzo di persone. Una nazione dentro la nazione, invisibile eppure enormemente presente.
Non posso fare a meno di pensare a quello che scrivevo cinquant’anni fa, quando denunciavo l’omologazione culturale prodotta dal nuovo potere consumistico. Ebbene, ecco il risultato: una società formalmente omologata nei desideri e nelle aspirazioni, ma brutalmente divisa nella possibilità di soddisfarli. Una società che ha unificato i sogni e moltiplicato le frustrazioni.
Che cosa significa che il reddito delle famiglie più abbienti è 5,5 volte quello delle famiglie più povere? Significa che il capitalismo consumistico ha mantenuto tutte le sue promesse: ha creato un’apparenza di uguaglianza mentre rafforzava e rendeva più sofisticate le disuguaglianze. Ha distrutto culture millenarie, dialetti, solidarietà popolari, sostituendole con il desiderio universale di merci. Ma le merci, come sappiamo, non sono per tutti.
Colpisce, in questi dati, la geografia della povertà: il Mezzogiorno con il 39,2% di persone a rischio esclusione contro l’11,2% del Nord-est. La questione meridionale, quella che tanto appassionò Gramsci, non si è risolta: si è trasformata. E non è più solo geografica, ma si è infiltrata nelle faglie sociali, nelle pieghe delle nuove configurazioni familiari. I monogenitori, ad esempio, con quel 32,1% di rischio povertà. O le famiglie con tre o più figli, al 34,8%. Ecco la nuova geografia dell’esclusione.
Quello che trovo più inquietante è il silenzio che avvolge questa realtà. Un silenzio fatto di chiacchiera televisiva, di intrattenimento incessante. La vera violenza del neo-capitalismo è questa: aver reso invisibile la sofferenza sociale, averla trasformata in statistica. Ma dietro ogni percentuale ci sono volti, corpi, esistenze. Ci sono quei volti che cercavo nelle borgate romane, quelle esistenze che tentavo di raccontare quando ancora la povertà aveva una sua dignità, una sua cultura, una sua lingua.
Oggi invece la povertà è muta, è vergogna, è esclusione dal grande rito collettivo del consumo. Il povero contemporaneo non è solo privo di risorse economiche: è privo di linguaggio, di rappresentazione, di dignità pubblica. È invisibile proprio mentre tutto diventa visibilità, spettacolo, esibizione. È questa la grande mutazione antropologica che temevo: non solo l’omologazione dei comportamenti, ma la perdita delle parole per dire la propria condizione.
Mi colpisce amaramente leggere che la diminuzione dei redditi in termini reali è particolarmente intensa nel Nord-est (-4,6%), proprio quella zona che un tempo chiamavo “le Italie”, con le sue culture particolari, i suoi dialetti, le sue tradizioni. Quella parte d’Italia che sembrava aver trovato una sua via alla modernizzazione conservando qualcosa della propria identità culturale. Ebbene, anche lì il modello ha fallito, anche lì la promessa di benessere si rivela ingannevole.
E che dire del fatto che il reddito delle famiglie con stranieri è inferiore di 5.400 euro a quello delle famiglie composte solo da italiani? Ecco il sottoproletariato del nuovo millennio, i nuovi esclusi. Ma attenzione: non si tratta della classe operaia di un tempo, portatrice di valori alternativi e di potenziale rivoluzionario. Si tratta di una massa frammentata, individualizzata, priva di coscienza collettiva. Esattamente ciò che il potere desidera.
Perché questo è il grande inganno del neo-capitalismo: aver distrutto non solo le condizioni materiali delle classi subalterne, ma soprattutto la loro coscienza di classe, la loro cultura alternativa, la loro capacità di creare linguaggi e visioni del mondo. La realtà descritta da questi numeri è una realtà di atomi sociali, non di classi. Di individui che soffrono privatamente, non di collettività che lottano pubblicamente.
Forse è per questo che la politica appare impotente di fronte a questi dati. Perché la politica presuppone un linguaggio comune, valori condivisi, la possibilità stessa di pensare un futuro diverso. Ma il presente consumistico ha distrutto tutto questo. Ha creato un eterno presente fatto di desideri sempre nuovi e sempre uguali. Ha reso impossibile immaginare alternative.
Eppure, paradossalmente, proprio in questo scenario desolante, non posso che pensare all’unica forma di resistenza che ancora ritengo possibile: una disperata vitalità pedagogica. Quando quasi un quarto della popolazione vive ai margini, quando la promessa di benessere si rivela così palesemente falsa per tanti, non si tratta di sperare in un risveglio collettivo – sarebbe un’illusione ingenua.
Ma forse proprio nell’insegnare questa devastazione, nel mostrare la miseria del presente ai giovani, nel trasmettere loro la consapevolezza della perdita, risiede l’ultimo compito dell’intellettuale. Un insegnamento senza consolazioni, una pedagogia della lucidità, che non promette soluzioni ma che almeno contrasta l’oblio, l’accettazione passiva, la falsa coscienza felice. Un corsaro atto educativo che non salverà il mondo, ma che almeno mantiene viva la memoria di ciò che abbiamo perduto.
Glossario
- Omologazione culturale: Concetto chiave nel pensiero pasoliniano che indica il processo attraverso cui il capitalismo consumistico elimina le differenze culturali, imponendo modelli standardizzati di comportamento e desiderio.
- Mutazione antropologica: Termine utilizzato da Pasolini per descrivere la trasformazione profonda della società italiana negli anni ’60 e ’70, che ha modificato non solo i comportamenti ma l’essenza stessa dell’uomo.
- Neo-capitalismo: Nella visione pasoliniana, fase del capitalismo caratterizzata dal consumismo e dalla creazione di bisogni artificiali, che sostituisce la repressione diretta con forme più sottili di controllo sociale.
Riferimenti bibliografici
- Pasolini, P. P. (1975). Scritti corsari. Garzanti.
- Pasolini, P. P. (1976). Lettere luterane. Einaudi.
- ISTAT (2024). Condizioni di vita e reddito delle famiglie | Anni 2023-2024. Istituto Nazionale di Statistica.