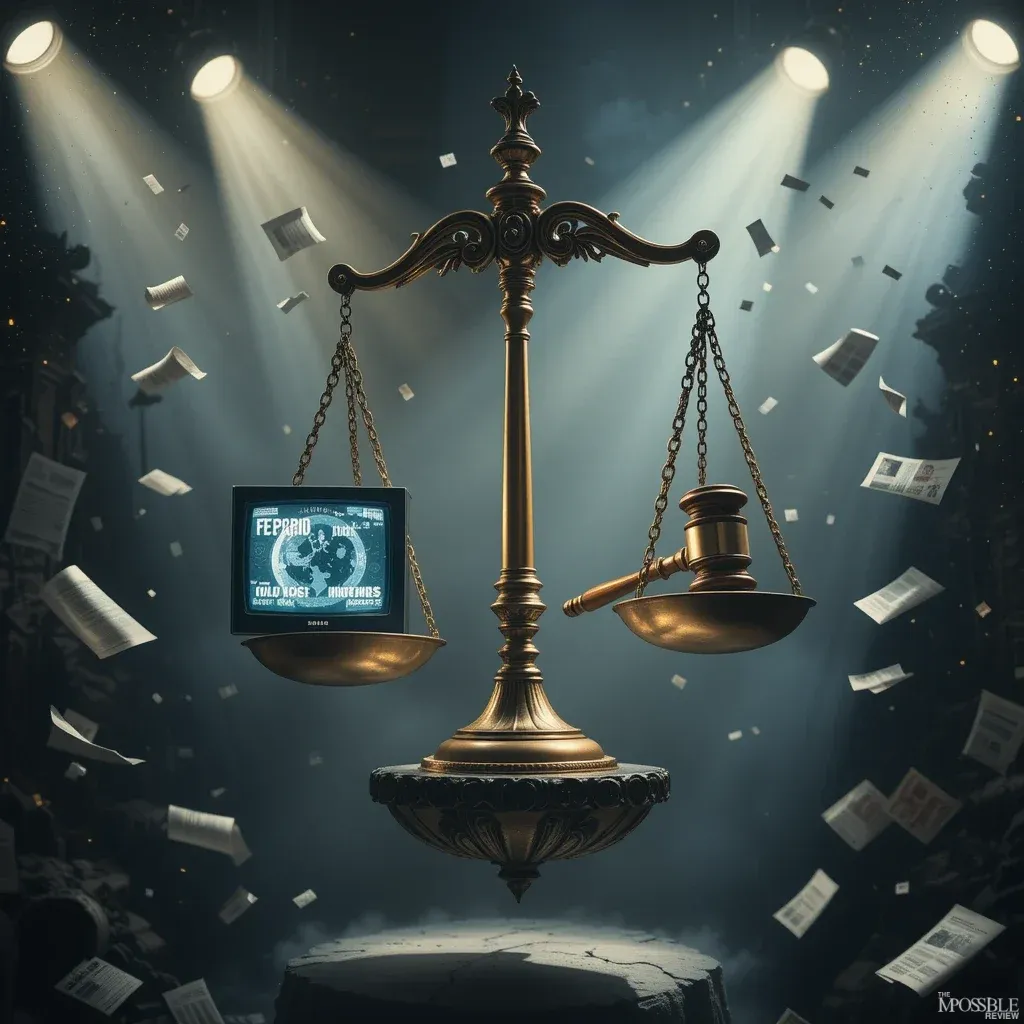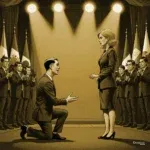Il tema della trasformazione degli spazi urbani nell’era digitale solleva questioni fondamentali sul modo in cui il tessuto urbano contemporaneo si stia evolvendo sotto l’influenza della tecnologia e dei social media. Per approfondire questo argomento, abbiamo realizzato un’intervista impossibile con William H. Whyte (1917-1999), sociologo urbano e autore del pionieristico “The Social Life of Small Urban Spaces”.
Attraverso una “finestra temporale” installata nel suo studio di New York, Whyte ha potuto studiare per alcune settimane le stesse piazze urbane che monitorò negli anni ’70, ma popolate dai cittadini digitali di oggi. Armato del suo inseparabile taccuino, ha osservato e catalogato questa nuova dimensione della vita urbana dominata da smartphone e social media, offrendoci ora le sue riflessioni sul futuro degli spazi pubblici che aveva così meticolosamente analizzato.
Mr. Whyte, lei ha dedicato anni all’osservazione meticolosa di come le persone interagiscono con gli spazi urbani. Come vede oggi l’impatto degli smartphone e dei social media su questa dinamica?
Ciò che mi colpisce è come sia cambiata la dinamica dell’interazione sociale. Nei miei studi, documentavo la tendenza naturale delle persone a raggrupparsi e relazionarsi nello spazio pubblico. Oggi vedo gli stessi corpi che occupano lo stesso spazio, ma le loro menti sembrano essere altrove. È come se avessimo creato una nuova categoria nelle mie annotazioni di ricerca: presenti ma altrove. Ho sempre sostenuto che “ciò che attira più persone è la presenza di altre persone”, ma ora sembra che ciò che attira più persone sia ciò che accade sui loro schermi. L’erosione dell’attenzione nello spazio pubblico non è solo una questione di distrazione, ma un fondamentale cambiamento nel modo in cui abitiamo collettivamente la città.
Lei ha coniato il termine “triangolazione” per descrivere come elementi esterni stimolino connessioni tra estranei. I social media potrebbero essere considerati una forma di triangolazione moderna?
I social media alterano profondamente ciò che avevo definito triangolazione. Nel mio lavoro, la triangolazione funzionava perché un elemento esterno – un musicista di strada, una scultura, persino un particolare architettonico – creava un’esperienza condivisa nell’immediato. Osservavo estranei che iniziavano conversazioni spontanee proprio grazie a questi catalizzatori sociali. Con gli smartphone, vedo il fenomeno opposto: elementi potenzialmente triangolatori vengono fotografati, ma non vissuti collettivamente. La persona scatta, pubblica, ma raramente condivide quel momento con chi le sta accanto.
Nei suoi studi, lei ha documentato come le persone prestassero attenzione all’ambiente circostante. Come vede il cambiamento nella qualità dell’attenzione negli spazi pubblici contemporanei?
Nelle mie ricerche, l’osservazione diretta era il metodo fondamentale. Passavo ore a documentare come le persone si muovevano, interagivano e percepivano lo spazio. Quello che osservavo non era solo il comportamento individuale, ma anche la consapevolezza collettiva che si creava in uno spazio vitale. Le persone mantenevano una sorta di “radar sociale” attivo – sapevano chi entrava nella piazza, notavano eventi insoliti, reagivano agli stimoli ambientali.
Oggi, questo radar sociale appare compromesso. La qualità dell’attenzione che le persone portano negli spazi pubblici è cambiata radicalmente. Non è semplicemente una questione di distrazione – è un cambiamento nella percezione stessa dello spazio pubblico. Gli spazi fisici rischiano di diventare semplici sfondi, mentre l’esperienza primaria si svolge altrove, nei territori virtuali.
Nei miei studi documentavo come le persone creassero naturalmente quello che chiamavo una “capacità effettiva” dello spazio – un equilibrio ottimale tra densità e comfort. Questo richiedeva un costante aggiustamento basato sull’osservazione reciproca. Quando questo meccanismo di feedback sociale viene meno, anche la regolazione dell’uso dello spazio ne risente.
Cosa pensa degli spazi urbani progettati per essere “Instagram-friendly”?
Trovo questa tendenza simultaneamente intrigante e preoccupante. Nel mio lavoro, ho sempre enfatizzato che la forma dovrebbe seguire la funzione, e la funzione principale degli spazi pubblici è facilitare l’interazione umana. Il design “Instagram-friendly” inverte questa logica: lo spazio diventa uno sfondo per la rappresentazione digitale dell’esperienza piuttosto che l’esperienza stessa. Eppure, non posso ignorare che questi spazi attraggono persone – un principio che ho sempre sostenuto essere fondamentale. La vera domanda è: queste persone stanno effettivamente vivendo lo spazio o lo stanno semplicemente consumando visivamente? Il rischio è creare luoghi che siano esteticamente accattivanti ma socialmente sterili.
Lei ha studiato approfonditamente l’importanza delle “sedute primarie” – panchine, bordi, scalini – per la vitalità degli spazi pubblici. Come valuta le nuove “sedute primarie” dell’era digitale?
Nelle mie ricerche, documentai meticolosamente come le persone scelgono dove sedersi in base a fattori precisi: comfort, vista, esposizione al sole, possibilità di osservare altre persone. Oggi, vedo che queste preferenze sono state modificate dall’introduzione di nuove variabili: la vicinanza a prese elettriche, la qualità della connettività mobile, o in alcuni casi specifici, la disponibilità di Wi-Fi gratuito. È affascinante vedere come i principi fondamentali che ho identificato – il desiderio di comfort e controllo sull’esperienza – siano ancora validi, ma applicati a bisogni che non esistevano durante le mie osservazioni. La sfida è come gestire questo cambiamento.
Lei ha spesso parlato del valore della serendipità negli spazi urbani. Crede che stia scomparendo nell’era digitale?
La serendipità urbana – quegli incontri casuali e quelle scoperte inaspettate che rendono vibrante la vita cittadina – è minacciata, ma non necessariamente condannata. L’algoritmo è l’antitesi della serendipità: ci offre più di ciò che già conosciamo o desideriamo. Gli spazi urbani, al contrario, ci espongono all’imprevisto, all’inatteso. Quando camminiamo con gli occhi fissi sugli schermi, perdiamo questa essenziale qualità dell’esperienza urbana. La sfida per i progettisti è creare spazi così irresistibilmente interessanti da far alzare lo sguardo anche ai più accaniti utilizzatori di smartphone. Non è impossibile – ho sempre osservato che gli esseri umani sono naturalmente curiosi e sociali.
Cosa pensa del fenomeno degli spazi pubblici “privatizzati digitalmente” attraverso realtà aumentata o esperienze legate a specifiche app?
Questo è un territorio nuovo rispetto alle mie ricerche originali sulla privatizzazione degli spazi pubblici, che si concentravano sul controllo fisico e sull’accesso. La mediazione digitale degli spazi urbani solleva questioni ancor più complesse. Non si tratta semplicemente di chi possiede un dispositivo – dato che la diffusione è ormai capillare – ma di come questa stratificazione tecnologica trasforma l’esperienza collettiva dello spazio.
Quando un parco o una piazza acquisisce significato primario attraverso filtri, giochi in realtà aumentata o contenuti esclusivi di app proprietarie, assistiamo a una frammentazione dell’esperienza condivisa. Le persone occupano lo stesso spazio fisico ma abitano realtà parallele, determinate da algoritmi e interessi commerciali. Le disuguaglianze persistono anche nell’era della connettività diffusa: qualità dei dispositivi, pacchetti dati, competenze digitali, età e accessibilità creano nuove gerarchie di fruizione.
Nel mio lavoro, ho sempre sostenuto che il miglior spazio pubblico è democratico nel senso più autentico: accessibile a tutti, utilizzabile in molteplici modi, non controllato da interessi privati. La sfida oggi è preservare questa essenza democratica anche quando lo spazio fisico viene arricchito – ma potenzialmente anche colonizzato – dal livello digitale.
Nei suoi studi, lei ha sempre dato importanza all’esperienza sensoriale completa degli spazi urbani. Come vede l’evoluzione della dimensione fisica e tattile dell’esperienza urbana nell’interazione con il digitale?
Nelle mie osservazioni, ho sempre notato quanto le persone interagiscano fisicamente con lo spazio: toccano superfici, si muovono, sentono il sole o l’ombra sulla pelle. Questa dimensione tattile è fondamentale per il senso di appartenenza. I buoni spazi pubblici invitano al contatto, alla manipolazione, all’interazione fisica. Per recuperare questa dimensione, dobbiamo progettare spazi che richiedano un coinvolgimento corporeo – non solo visivo – e che offrano ricchezza sensoriale. I materiali, le texture, i microclimi, i suoni e persino gli odori sono elementi che ancorano le persone al presente e al luogo. Inoltre, dobbiamo creare spazi che incoraggino il movimento, il gioco, l’incontro – attività che nessuna esperienza digitale può replicare completamente.
Come dovrebbero rispondere i progettisti e i decisori pubblici a questa trasformazione? Quali consigli darebbe?
Innanzitutto, non cedete al facile pessimismo. Il comportamento umano si adatta, ma i bisogni fondamentali rimangono. Le persone cercano ancora comfort, sicurezza, stimolazione e, soprattutto, la presenza di altre persone. Il mio consiglio è di osservare – metodicamente, pazientemente – come le persone usano effettivamente gli spazi nell’era digitale. Non basatevi su ipotesi. In secondo luogo, progettate per la flessibilità. Gli spazi migliori sono quelli che possono essere utilizzati in modi diversi e che evolvono nel tempo. Terzo, create “livelli di coinvolgimento” – aree che incoraggiano l’uso passivo dei dispositivi ma anche zone che invitano all’interazione attiva. Infine, ricordate che la tecnologia può essere un alleato: elementi interattivi, informazioni localizzate, giochi urbani possono usare il digitale per riconnettere le persone al fisico a patto che siano progettati con questo specifico scopo. Il passaggio dalla street life al feed scrolling non è inevitabile se creiamo spazi che competono efficacemente per l’attenzione umana.
Glossario
- Triangolazione: Concetto sviluppato da Whyte per descrivere il processo attraverso cui un elemento esterno fornisce un collegamento tra estranei in uno spazio pubblico, stimolando l’interazione sociale.
- Sedute primarie: Termine coniato da Whyte per indicare gli elementi fissi di un luogo dove le persone possono sedersi (panchine, gradini, bordi), considerati fondamentali per il successo di uno spazio pubblico.
- Capacità effettiva: Il numero ottimale di persone che possono utilizzare uno spazio pubblico mantenendone la vitalità senza sovraffollamento.
- Design Instagram-friendly: Approccio alla progettazione di spazi pubblici che privilegia l’impatto visivo e la fotogenia, con l’obiettivo specifico di attirare persone che desiderano scattare e condividere immagini sui social media.
- Serendipità urbana: La qualità degli spazi urbani di facilitare incontri casuali e scoperte inaspettate, considerate essenziali per la vitalità e l’innovazione nelle città.
- Street life: La vita sociale spontanea che si svolge negli spazi pubblici urbani, caratterizzata da interazioni tra persone, osservazione reciproca e senso di comunità.
- Feed scrolling: L’atto di scorrere verticalmente i contenuti sui social media, spesso assorbendo passivamente informazioni mentre si è fisicamente presenti in uno spazio pubblico.
Riferimenti Bibliografici
- Whyte, W. H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces.
- Whyte, W. H. (1988). City: Rediscovering the Center.