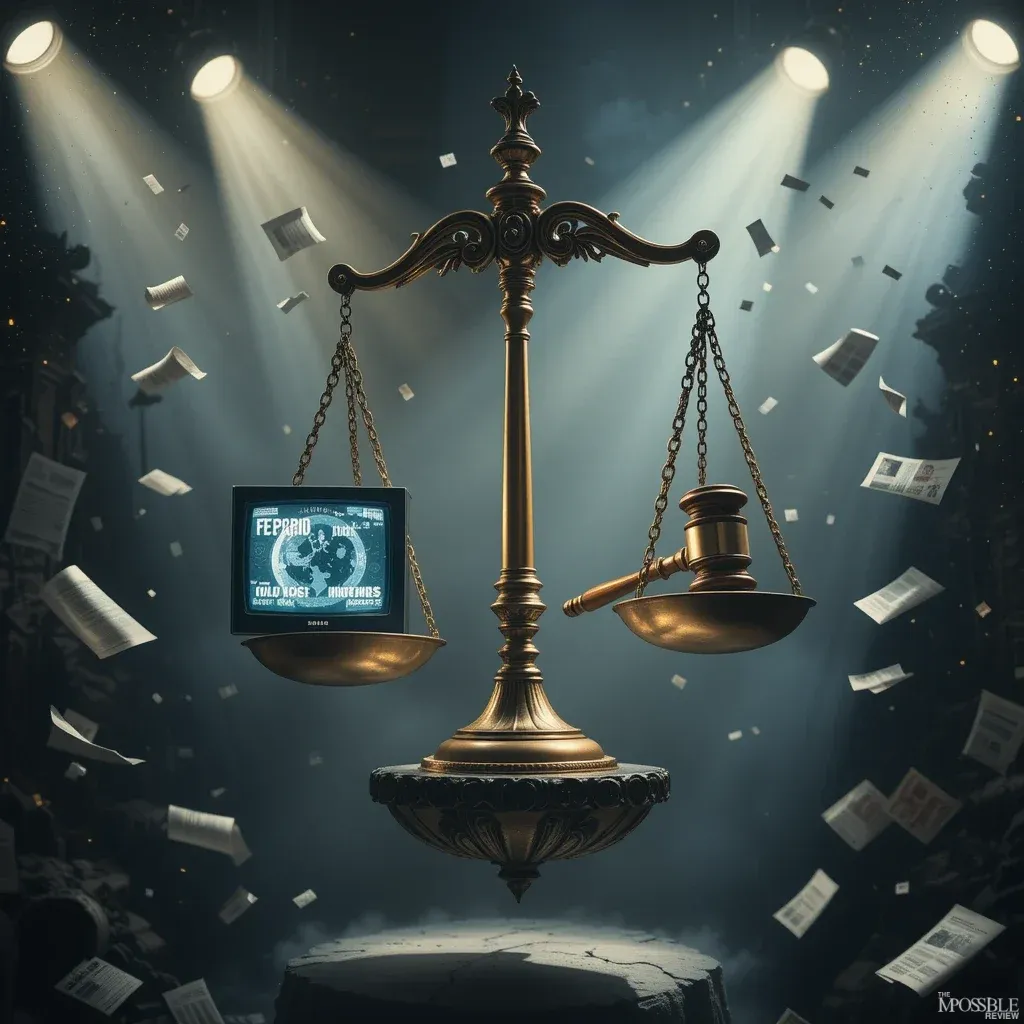Come riportato da Open Online, l’ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione ha classificato Alternative für Deutschland (AfD) come “partito di estrema destra”, con posizioni incompatibili con l’ordine democratico. Questa classificazione solleva interrogativi fondamentali sui limiti della tolleranza democratica e su come le democrazie debbano comportarsi con forze potenzialmente antidemocratiche.
Per l’occasione, abbiamo realizzato un’intervista impossibile con Karl Popper, il cui “paradosso della tolleranza” rappresenta uno dei contributi più significativi al dibattito su quanto una società aperta debba tollerare l’intolleranza prima di rischiare l’autodistruzione. Il filosofo austriaco, naturalizzato britannico, è particolarmente indicato per affrontare questo tema grazie al suo vissuto durante l’ascesa del nazismo, alla sua esperienza diretta della fragilità delle democrazie e al suo lavoro fondamentale sulla società aperta e i suoi nemici.
Professor Popper, l’intelligence tedesca ha classificato AfD come partito di estrema destra con posizioni incompatibili con l’ordine democratico. Secondo lei, è legittimo che uno stato democratico consideri la messa al bando di un partito politico?
Dobbiamo essere estremamente cauti quando consideriamo misure così drastiche, ma non possiamo dimenticare che la democrazia non è semplicemente la regola della maggioranza. La democrazia, come l’ho sempre concepita, è un sistema di istituzioni che permette il cambiamento politico senza violenza e che protegge i cittadini dalla tirannia. Nel mio lavoro “La società aperta e i suoi nemici”, ho elaborato il “paradosso della tolleranza”: la tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza stessa. Se estendiamo la tolleranza illimitata anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo preparati a difendere una società tollerante contro l’assalto degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi.
In questo senso, trovo particolarmente perspicace l’articolo 21 della Costituzione tedesca, che dichiara incostituzionali i partiti che mirano a minare o abolire l’ordinamento democratico liberale. Questa disposizione costituzionale rappresenta una forma istituzionalizzata del principio che ho sempre difeso: una democrazia ha il diritto di proteggersi. È interessante notare come la Germania, dopo l’esperienza traumatica del nazismo, abbia incorporato nella sua costituzione meccanismi espliciti di autodifesa democratica.
Questo significa che ritiene giustificata la messa al bando di AfD?
Non sto suggerendo azioni specifiche contro un partito particolare, sarebbe imprudente da parte mia. Piuttosto, sto affermando un principio: le democrazie hanno non solo il diritto, ma il dovere di autodifendersi. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato con estrema cautela e solo in presenza di una minaccia reale e sostanziale. La soppressione di opinioni, per quanto spiacevoli possano essere, dovrebbe essere considerata solo quando queste costituiscono un incitamento diretto alla violenza o minacciano in modo concreto le istituzioni democratiche.
La questione cruciale è: AfD rappresenta una minaccia di questo tipo? Questo richiede un’analisi attenta delle sue azioni e dichiarazioni concrete, non solo della sua retorica. La Corte Costituzionale federale tedesca, nell’applicare l’articolo 21, ha stabilito criteri molto rigorosi per la messa al bando di un partito. Non basta che un partito esprima idee contrarie ai valori democratici; deve attivamente lavorare per sovvertire l’ordine democratico ed avere una reale possibilità di successo in questo intento. Questa cautela procedurale è essenziale per evitare abusi.
Considerando che AfD ha ottenuto percentuali significative alle recenti elezioni, come conciliare la legittimità democratica derivante dal voto con la potenziale minaccia alle istituzioni democratiche?
Questa è esattamente l’essenza del paradosso democratico. Il voto popolare conferisce legittimità procedurale, ma la democrazia non può ridursi a un mero meccanismo procedurale. Una democrazia sana richiede ciò che ho chiamato una “cultura della critica”, in cui le idee possono essere liberamente discusse e confutate attraverso il dibattito razionale.
Il problema sorge quando un movimento utilizza le procedure democratiche con l’intento di abolire il sistema democratico stesso una volta ottenuto il potere. È questo il modello che abbiamo osservato con i totalitarismi del XX secolo. Hitler giunse al potere attraverso mezzi formalmente legali, ma con l’intento di distruggere il sistema che gli aveva permesso di accedervi.
La Costituzione tedesca affronta questo paradosso attraverso un’altra disposizione notevole: la cosiddetta “clausola di eternità” dell’articolo 79, comma 3, che rende intoccabili alcuni principi fondamentali, come la dignità umana, lo stato di diritto, la democrazia, il federalismo e lo stato sociale, anche attraverso revisioni costituzionali votate a maggioranza qualificata. Questa clausola rappresenta un limite invalicabile al principio di maggioranza, un riconoscimento formale che esistono valori democratici fondamentali che non possono essere abrogati nemmeno attraverso procedure democratiche.
Quali strumenti ha a disposizione una democrazia per proteggersi senza tradire i propri principi?
La risposta non è semplice, ma posso delineare alcuni strumenti. Innanzitutto, l’educazione civica: una cittadinanza informata è la prima linea di difesa contro il totalitarismo. Secondo, istituzioni robuste con controlli ed equilibri efficaci che limitino la concentrazione del potere. Terzo, un sistema giudiziario indipendente che possa intervenire quando i diritti fondamentali sono minacciati. Quarto, una stampa libera che possa esporre e criticare le tendenze autoritarie.
In casi estremi, la Costituzione stessa può fornire meccanismi di autodifesa, come la “democrazia militante” incorporata in quella tedesca. La Germania ha adottato un approccio particolarmente articolato in questo senso, con l’articolo 21 sul bando dei partiti antidemocratici, l’articolo 18 sulla limitazione dei diritti fondamentali per chi li usa per combattere l’ordine democratico, e la già menzionata “clausola di eternità”.
Questi strumenti devono essere utilizzati con prudenza, riconoscendo che esiste sempre una tensione tra la protezione della democrazia e il rispetto delle sue procedure. La sfida è utilizzare questi meccanismi solo quando necessario, senza cadere nella tentazione di abusarne per reprimere il dissenso legittimo. La Corte Costituzionale tedesca ha mostrato grande saggezza nel mantenere questo equilibrio, applicando l’articolo 21 solo in casi estremi, come per il partito neonazista SRP nel 1952 e il partito comunista KPD nel 1956.
L’ex cancelliere Scholz ha frenato l’idea di una messa al bando immediata. Ritiene sia un approccio saggio?
La cautela di Scholz riflette la complessità della questione. La messa al bando di un partito politico è una misura estrema che dovrebbe essere considerata solo dopo che tutti gli altri meccanismi di difesa democratica sono stati esauriti. Il rischio di una reazione affrettata è di confermare la narrativa vittimistica che questi movimenti spesso promuovono, rafforzando paradossalmente il loro appello.
La vera sfida per una democrazia è confrontarsi con le cause profonde che alimentano il sostegno a partiti come AfD: preoccupazioni economiche, disillusione verso l’establishment politico, ansie socio-culturali. Affrontare queste cause richiede riforme sostanziali e un dialogo genuino, non solo misure repressive.
Inoltre, la struttura federale della Germania, protetta dalla “clausola di eternità”, offre un ulteriore livello di sicurezza contro prese di potere autoritarie. La dispersione del potere tra il governo federale e i Länder rende più difficile per un singolo partito assumere un controllo totalizzante delle istituzioni. Questa architettura costituzionale rappresenta una forma di “ingegneria istituzionale” che crea ostacoli strutturali all’ascesa di forze antidemocratiche, riducendo la necessità di interventi repressivi diretti.
Lei ha vissuto l’ascesa del nazismo in Europa. Vede paralleli con la situazione attuale?
Ci sono sempre lezioni da trarre dalla storia, ma dobbiamo essere cauti con le analogie dirette. La Repubblica di Weimar cadde non solo per la forza del nazismo, ma anche per la debolezza delle sue istituzioni democratiche e la mancanza di una cultura democratica radicata. Le democrazie contemporanee sono generalmente più robuste, con istituzioni più sviluppate e meccanismi di controllo più efficaci. Tuttavia, sarebbe un errore fatale assumere che le democrazie moderne siano immuni dai pericoli che hanno afflitto Weimar. La democrazia è sempre un progetto incompiuto che richiede vigilanza costante.
Quale consiglio darebbe ai cittadini tedeschi e alle democrazie europee che si confrontano con l’ascesa di movimenti populisti di estrema destra?
Il mio consiglio è di mantenere viva la tradizione critica razionale che è al cuore della civiltà occidentale. Le idee pericolose devono essere confutate con argomentazioni migliori, non semplicemente soppresse. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere i limiti della tolleranza: quando un movimento dimostra chiaramente l’intento di distruggere le basi della società aperta, abbiamo il diritto e il dovere di resistere. Ma la resistenza più efficace non è la repressione, bensì la costruzione di istituzioni democratiche più forti e più ricettive, capaci di affrontare le legittime preoccupazioni dei cittadini senza sacrificare i principi fondamentali di libertà, uguaglianza e rispetto per i diritti umani. In ultima analisi, la democrazia si difende non solo con le leggi, ma con la partecipazione attiva e critica di cittadini impegnati nella sua preservazione.
Glossario
- Società aperta: Concetto chiave nella filosofia di Popper che indica una società caratterizzata dal governo democratico, dalla libertà di pensiero, dal pluralismo e dal rispetto dei diritti individuali, in contrapposizione alle società chiuse o autoritarie.
- Democrazia militante: Principio giuridico-costituzionale, presente nella Costituzione tedesca, secondo cui lo stato democratico ha il diritto di difendersi attivamente contro forze che cercano di minare o abolire l’ordine democratico costituzionale.
- Cultura della critica: Per Popper, l’atteggiamento intellettuale fondamentale per il progresso della conoscenza e per il funzionamento della democrazia, basato sulla discussione critica razionale e sul riconoscimento della fallibilità umana.
Riferimenti bibliografici
- Popper, K. (1945). La società aperta e i suoi nemici (The Open Society and Its Enemies). Routledge.
- Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), 1949.