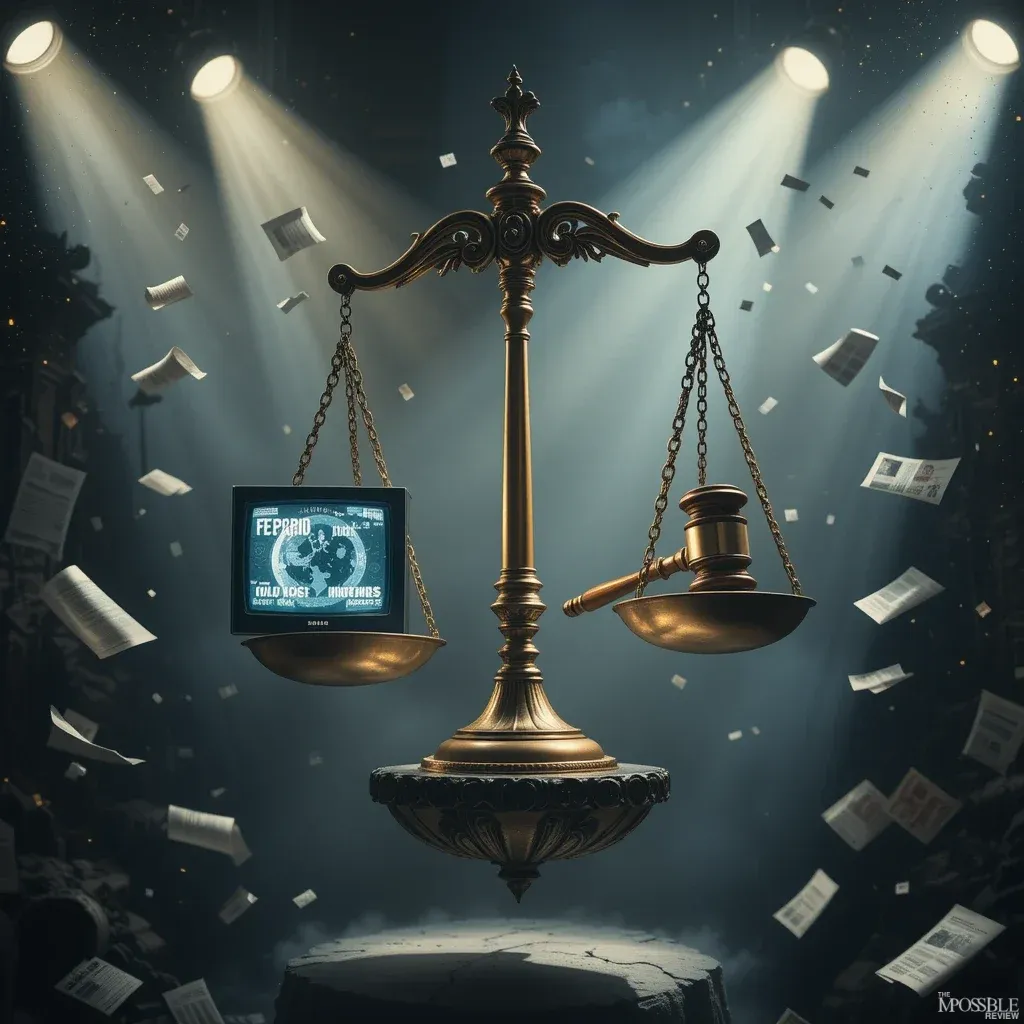Il tema riguarda l’introduzione delle ‘Community Notes’ sulle piattaforme di Meta (Facebook, Instagram e Threads), un sistema di fact-checking gestito dagli utenti che sostituirà i verificatori di terze parti, come riportato da Wired. Abbiamo chiesto a Walter Lippmann, uno dei più influenti giornalisti e teorici della comunicazione del XX secolo, di analizzare questa transizione. Il suo pensiero pionieristico sull’opinione pubblica, sul ruolo dei media e sulla formazione del consenso lo rende particolarmente adatto ad esaminare come le piattaforme social stiano ridefinendo i meccanismi di verifica delle informazioni e le implicazioni di questo cambiamento per la democrazia contemporanea.
Il recente annuncio di Meta riguardo all’implementazione delle ‘Community Notes’ sulle proprie piattaforme rappresenta l’ultimo capitolo di una lunga e complessa storia: la persistente illusione che la verità possa emergere spontaneamente dal consesso collettivo, senza mediazioni professionali o istituzionali.
Nel 1922 avevo già identificato i pericoli di affidare la costruzione della realtà pubblica alle percezioni individuali prive di adeguato filtro critico. Nel mio ‘Opinione Pubblica’ sostenevo, infatti, che la democrazia moderna soffre di una contraddizione fondamentale: presuppone cittadini onniscienti mentre la complessità del mondo reale rende impossibile tale condizione. Oggi questa contraddizione non solo persiste, ma si amplifica nel vostro ambiente digitale.
L’iniziativa di Meta, seguendo l’esempio di X, invita gli utenti a diventare verificatori di fatti. Si propone così di creare un sistema apparentemente democratico dove la verità emergerebbe dal consenso della comunità. Ma possiamo davvero chiamarlo progresso democratico? O non è piuttosto l’ennesima manifestazione di quello che definivo ‘pseudo-ambiente’, una rappresentazione semplificata e distorta della realtà che sostituisce la realtà stessa?
Questa illusione della saggezza delle folle nella verifica dei fatti non è un’innovazione, ma un vecchio errore con nuove vesti digitali. Nel 1835, quando Alexis de Tocqueville osservava la democrazia americana, notava già come l’opinione della maggioranza tendesse a sostituirsi all’autorità delle figure competenti, creando una ‘tirannia della maggioranza’ particolarmente insidiosa in campo intellettuale. Certamente, all’interno di queste folle esistono individui competenti e informati – il problema è la mancanza di meccanismi che permettano alla loro voce di emergere con l’autorità che meritano.
Gli ‘stereotipi’, concetto che ho introdotto nel dibattito pubblico moderno, oggi trovano terreno fertile nelle piattaforme digitali. Questi modelli mentali preconfezionati, che utilizziamo per classificare e comprendere rapidamente la realtà, non vengono superati dal fact-checking comunitario, ma rischiano di essere rafforzati. Un sistema che privilegia il consenso diffuso potrebbe infatti premiare non la verità oggettiva, ma la narrazione più conforme agli stereotipi dominanti nel gruppo.
Meta sostiene che ‘non sarà Meta a decidere cosa viene valutato o scritto, ma i collaboratori della community’. Questa affermazione rivela una concezione ingenua della tecnologia come strumento neutrale. Le piattaforme non sono spazi vuoti: sono architetture complesse che indirizzano il comportamento umano attraverso algoritmi, interfacce e incentivi specifici. Rinunciando apparentemente al controllo editoriale, Meta non sta delegando potere agli utenti, ma sta semplicemente ridisegnando il sistema di influenze che plasma l’opinione pubblica.
I sostenitori di questo modello partecipativo solleveranno sicuramente un’obiezione legittima: perché dovremmo fidarci del fact-checking nelle mani di una grande società privata più che del giudizio collettivo degli utenti? Questa è una falsa dicotomia che oscura la vera questione.
Non ho mai sostenuto che il potere di determinare la verità debba risiedere esclusivamente nelle mani di interessi privati – al contrario. In ‘Liberty and the News’ argomentavo che la stampa libera, quando dominata da interessi commerciali, può distorcere l’informazione tanto quanto qualsiasi propaganda statale. Il problema è che Meta sta semplicemente trasferendo la responsabilità senza trasferire gli strumenti necessari per esercitarla efficacemente. La vera alternativa non è tra società private o folle, ma tra sistemi progettati primariamente per il profitto e sistemi progettati primariamente per la verità fattuale.
Le istituzioni giornalistiche professionali, con i loro standard etici, metodologie verificabili e accountability pubblica, rappresentano un modello alternativo ad entrambi gli estremi. Meta non sta democratizzando la verità: sta semplicemente esternalizzando un costo operativo, mascherando questa decisione economica come un esperimento di democrazia digitale. Il potere di stabilire quale verità prevalga non viene democratizzato, ma redistribuito secondo logiche che premiano visibilità, polarizzazione e coinvolgimento emotivo – non accuratezza o rilevanza.
È rivelatore esaminare i criteri stabiliti da Meta per i suoi verificatori di fatti: un’età superiore ai 18 anni, un account attivo da sei mesi, un numero di telefono verificato. Nel mio ‘The Phantom Public’, sostenevo che una democrazia funzionante richiede una partecipazione qualificata in base alla materia trattata. Chi possiede conoscenza specialistica dovrebbe avere un peso maggiore rispetto ai non esperti. Meta, al contrario, cancella completamente questa distinzione, trattando sei mesi di presenza sulla piattaforma come se fosse equivalente a una reale esperienza o competenza tematica. È come permettere a chiunque abbia una tessera elettorale di presiedere una commissione scientifica – un simulacro di rigore che maschera l’abbandono della responsabilità editoriale.
È interessante notare come si giustifichi questo cambiamento citando studi secondo cui ‘gli utenti si dimostrano meglio disposti a modificare i contenuti fake in risposta alle note della community’. Questo presuppone che l’obiettivo primario sia la correzione dei comportamenti individuali piuttosto che l’accuratezza dell’informazione pubblica. Si tratta di un sottile slittamento dal concetto di verità come corrispondenza ai fatti al concetto di verità come costruzione sociale.
Il requisito che le note siano pubblicate solo quando ‘i collaboratori con diversi punti di vista sono ampiamente d’accordo’ rivela un’altra contraddizione: si cercano pluralismo e consenso simultaneamente. Ma la verità, specialmente su questioni complesse, è spesso scomoda e inizialmente minoritaria. Il sistema proposto rischia di privilegiare le mezze verità accettabili su cui è più facile trovare consenso rispetto alle verità scomode che sfidano le opinioni consolidate.
Ciò che manca in questo approccio è il riconoscimento che l’informazione di qualità richiede competenza, risorse e indipendenza – non solo buone intenzioni collettive. I fact-checker professionali, con tutte le loro imperfezioni, offrono almeno un metodo verificabile e responsabile. Sostituirli completamente con il giudizio collettivo di utenti non addestrati equivale a confondere democrazia con oclocrazia.
Il vero rischio non è solo la diffusione di informazioni false, ma l’erosione graduale del concetto stesso di verità fattuale come riferimento comune.
Meta e le altre piattaforme dovrebbero riconoscere la loro responsabilità come custodi dello spazio pubblico digitale, investendo in sistemi ibridi che combinino la partecipazione degli utenti con l’expertise professionale. Solo così potremo affrontare la sfida fondamentale della democrazia nell’era digitale: come costruire un’opinione pubblica informata in un mondo troppo complesso per essere compreso attraverso l’esperienza diretta di qualsiasi individuo.
Glossario dei Concetti Chiave
- Pseudo-ambiente: Concetto sviluppato da Lippmann che indica la rappresentazione mentale e mediata della realtà che influenza il comportamento umano più della realtà oggettiva stessa.
- Community Notes: Sistema di fact-checking partecipativo implementato prima da X e ora da Meta, che permette agli utenti di aggiungere contesto e correzioni ai contenuti pubblicati.
- Fact-checking: Processo di verifica dell’accuratezza fattuale di affermazioni pubblicate o diffuse attraverso i media.
- Oclocrazia: Governo della folla o della massa, spesso usato in senso peggiorativo per indicare una degenerazione della democrazia in cui prevale l’opinione più rumorosa o numerosa.
Riferimenti Bibliografici
- Lippmann, W. (1922). Public Opinion.
- Lippmann, W. (1925). The Phantom Public.
- Lippmann, W. (1920). Liberty and the News.