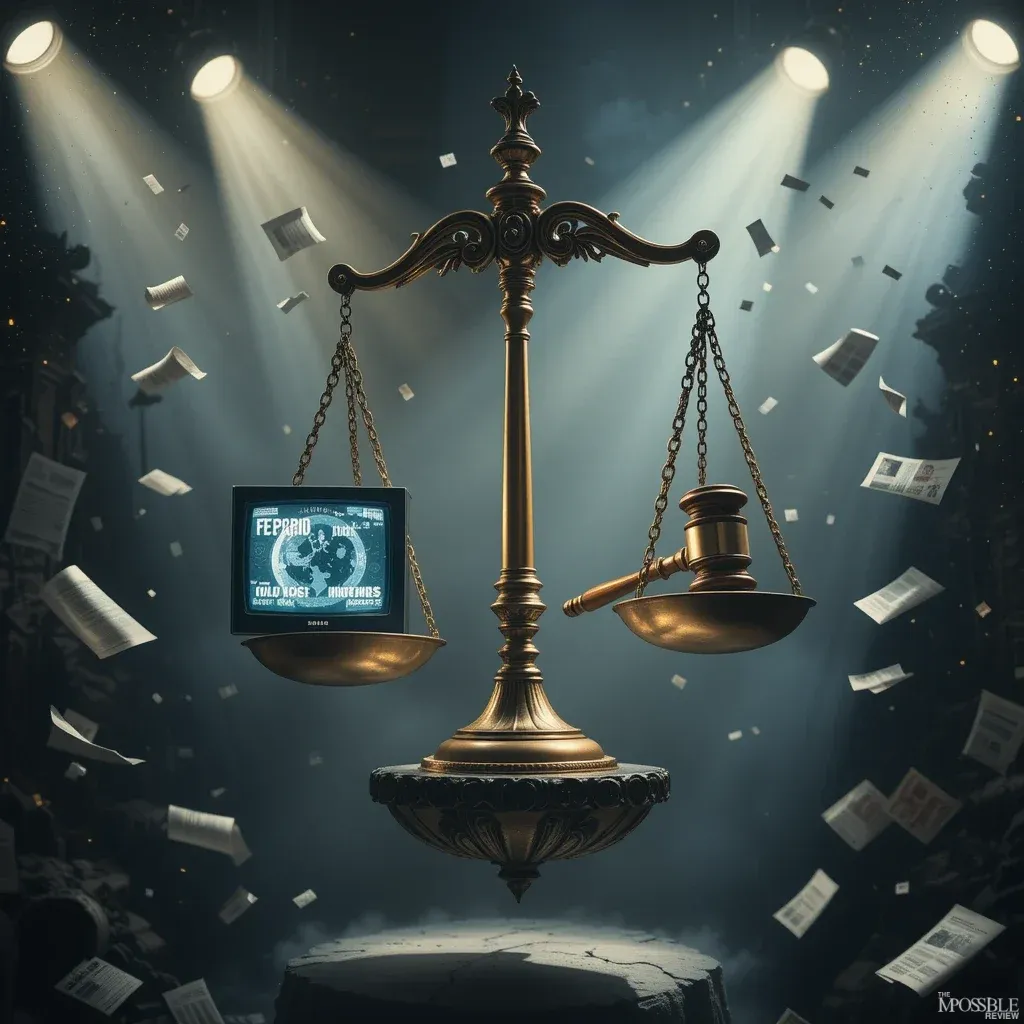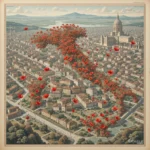In un’epoca di profondi sconvolgimenti che richiamano alla memoria i grandi conflitti del passato, ci troviamo a riflettere sul valore sempre più marginale della storia nelle società moderne, dominate dalla tecnica e dalla performance. Per esplorare questa dissociazione tra insegnamenti storici e presente, abbiamo immaginato un’intervista impossibile con Martin Heidegger, uno dei filosofi più influenti del XX secolo. La sua profonda analisi del rapporto tra uomo, tecnica e temporalità offre una prospettiva unica per comprendere la nostra condizione contemporanea, in cui il passato viene costantemente svalutato a favore di un futuro orientato al mero progresso tecnologico senza scopo ulteriore.
Professor Heidegger, viviamo in un’epoca di grandi sconvolgimenti globali che sembrano echeggiare i conflitti del passato. Eppure l’umanità contemporanea appare incapace di apprendere dalla storia. Come spiega questa apparente amnesia collettiva?
Ciò che lei chiama “amnesia” è in realtà un sintomo di qualcosa di più profondo. Non si tratta semplicemente di dimenticare, ma di un cambiamento radicale nel modo in cui l’uomo contemporaneo si rapporta all’essere e al tempo. Nella mia opera principale, “Essere e Tempo”, ho mostrato come l’esistenza umana – il Dasein, l’esser-ci – sia fondamentalmente temporale. L’uomo autentico comprende la propria esistenza come un evento storico, come un dispiegarsi tra nascita e morte, in un orizzonte di significati ereditati dal passato e proiettati verso il futuro. Oggi, però, l’uomo vive in quello che chiamerei un “presente assoluto”, sradicato dalla tradizione e ossessionato da un futuro concepito non come possibilità autentica ma come mera estensione tecnica del presente, un futuro proiettato esclusivamente al miglioramento tecnico, senza interrogarsi sul suo significato esistenziale.
Quindi è la tecnica moderna a impedirci di valorizzare la storia? In che modo esattamente?
La tecnica moderna non è semplicemente uno strumento neutrale che l’uomo utilizza. È piuttosto un modo complessivo di svelare l’essere che io ho chiamato l’impianto o imposizione. In questo modo di disvelamento, tutto – la natura, gli altri esseri umani, persino il tempo – viene ridotto a “fondo”, a risorsa utilizzabile, a stock disponibile per il calcolo e la manipolazione. La storia, in questo contesto, non viene semplicemente dimenticata; viene trasformata in un deposito di dati, in un archivio da cui estrarre informazioni utili quando servono, ma priva di un’autentica forza normativa sul presente. L’uomo della tecnica non si comprende più come erede di una tradizione che lo precede e lo supera; si vede invece come padrone e misura di tutte le cose, compreso il passato.
Nei social media odierni vediamo una sorta di ossessione per l’immediato, per la novità costante. È questo un esempio di ciò di cui parla?
La questione presuppone una mia familiarità con questi fenomeni contemporanei. La redazione mi ha mostrato ciò che chiamate “social media” e ho constatato che rappresentano la perfetta manifestazione di quanto avevo già individuato come tendenza essenziale della modernità tecnica. Essi incarnano quella relazione col tempo che definivo “inautentica”: la dispersione nella chiacchiera, l’ossessione per la novità superficiale, l’illusione di comprensione senza reale profondità. Questi media trasformano la storia in frammenti disconnessi, consumati e dimenticati istantaneamente. Sono la realizzazione estrema della dittatura del “si” impersonale (das Man) che avevo teorizzato: un “si dice”, “si pensa”, “si fa” dove nessuno si chiede chi sia davvero questo “si” collettivo. Nei vostri social media, le opinioni acquisiscono autorità solo per visibilità e ripetizione, non per valore intrinseco. È una dittatura tanto più efficace quanto invisibile, dove la responsabilità individuale si dissolve in un flusso comunicativo ormai privo di qualsiasi ancoraggio all’esperienza autentica.
Lei parla di un futuro ridotto al “miglioramento della tecnica”. Questo è particolarmente evidente nel dibattito sull’intelligenza artificiale, dove spesso sembra che la tecnologia avanzi senza un chiaro scopo umano o etico.
Mi sono trovato dinanzi a ciò che chiamate ‘intelligenza artificiale’ – un termine già di per sé rivelatore, poiché presuppone che l’intelligenza sia riducibile a calcolo e simulazione. Ho osservato questi sistemi che pretendono di ‘pensare’ e ‘apprendere’, e in essi ho riconosciuto immediatamente ciò che avevo già scorto nell’essenza della tecnica moderna: l’apoteosi del pensiero calcolante che ho sempre contrapposto al pensiero meditante. Non è un caso che i vostri dibattiti siano dominati da questioni di efficienza, ottimizzazione, velocità – tutti valori puramente tecnici. Ciò che manca è la domanda fondamentale: a che scopo? Verso quale comprensione dell’essere umano ci stiamo dirigendo? La tecnica moderna, ed ora l’intelligenza artificiale, procedono come se il loro sviluppo fosse un fine in sé. Come scrissi nel saggio sulla tecnica, il disvelamento che governa la tecnica moderna non crea nel senso di portare alla luce, ma impone, calcola, sfrutta. L’automazione del pensiero è l’estrema conseguenza di questo processo.
Cosa significa allora recuperare un rapporto autentico con la storia nel nostro tempo?
Non si tratta semplicemente di studiare più storia o di preservare monumenti. Si tratta di recuperare ciò che ho chiamato la storicità dell’esistenza umana. L’uomo deve riconoscersi nuovamente come un essere gettato in un mondo storico, che lo precede e lo determina, eppure aperto a possibilità autentiche di esistenza. Questo significa abbandonare l’illusione del controllo totale che la tecnica ci suggerisce. Significa riscoprire la capacità di ascoltare ciò che la tradizione ha ancora da dirci, non come informazione da processare, ma come appello esistenziale.
È ancora possibile questo ascolto in un mondo dominato dai dispositivi digitali, dagli algoritmi, dall’automazione?
“Dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva” – così diceva Hölderlin [Friedrich Hölderlin, poeta tedesco, 1770 – 1843 n.d.r.] che ho spesso citato nei miei scritti. La stessa tecnica che minaccia di alienarci dalla nostra essenza storica può diventare occasione per un nuovo pensiero, se affrontata con la giusta disposizione. Non si tratta né di rifiutare la tecnica – cosa impossibile – né di abbandonarsi acriticamente ad essa, ma di ciò che ho chiamato Gelassenheit, il distacco sereno o l’abbandono. Questo significa dire contemporaneamente sì e no alla tecnica: sì al suo uso inevitabile, no alla sua pretesa di determinare interamente il nostro modo di pensare.
In termini concreti, significa recuperare pratiche che ci ricollegano al mondo in modi non puramente strumentali: il cammino nella natura, l’artigianato radicato nella tradizione, la meditazione sulla potenza originaria del linguaggio poetico. Queste pratiche non sono semplici attività, ma modi di apertura all’essere che ci permettono di superare l’oblio della storia causato dalla tecnica. Quando camminiamo lungo un sentiero di campagna, non incontriamo semplicemente alberi e pietre, ma un paesaggio formato da generazioni che hanno vissuto in relazione con quella terra. Quando ci rivolgiamo alla poesia, non leggiamo solo parole, ma entriamo in dialogo con una tradizione di pensiero che conserva domande fondamentali sull’esistenza. La storia non è allora più concepita come un catalogo di eventi passati da utilizzare, ma come la dimensione stessa in cui il nostro essere si dispiega e acquista significato.
Un’ultima domanda: quali pensa siano le conseguenze ultime di questa perdita di senso storico per le società contemporanee?
Una società senza un rapporto autentico con la propria storia è una società destinata a ripetere gli errori del passato, ma in forme ancora più distruttive, proprio perché amplificati dalla potenza della tecnica moderna. Non è un caso che la nostra epoca veda il ritorno di nazionalismi aggressivi, fondamentalismi religiosi, conflitti etnici – tutte manifestazioni di un’umanità che, avendo perso il legame vitale con la tradizione, cerca disperatamente radici in simulacri identitari. Il vero pericolo non è che la tecnica distrugga l’uomo fisicamente – sebbene questa possibilità esista – ma che lo trasformi interiormente, facendogli dimenticare la domanda sul senso dell’essere, rendendolo incapace di abitare poeticamente questa terra, come direbbe ancora Hölderlin. Ma finché questa domanda potrà essere ancora posta, finché alcuni continueranno a pensare oltre il calcolo e l’utilità, rimarrà aperta la possibilità di un altro inizio.
Glossario
- Dasein: Letteralmente “esser-ci”, è il termine con cui Heidegger designa l’esistenza umana nella sua specificità di essere aperta alla comprensione dell’essere.
- Gestell: Traducibile come “impianto” o “imposizione”, indica il modo in cui la tecnica moderna svela l’essere, riducendo tutto a risorsa utilizzabile e calcolabile.
- Bestand: Il “fondo” o “impiego”, il modo in cui gli enti si manifestano nell’epoca della tecnica, non più come oggetti stabili ma come risorse disponibili.
- Das Man: Il “si” impersonale, la dimensione pubblica e inautentica dell’esistenza in cui l’individuo si conforma ai modi di pensare e agire dominanti.
- Geschichtlichkeit: La “storicità”, la caratteristica dell’esistenza umana di essere costitutivamente storica, inserita in una tradizione che la precede e la definisce.
- Rechnendes Denken: Il “pensiero calcolante”, orientato all’efficienza, al controllo, alla manipolazione degli enti.
- Besinnliches Denken: Il “pensiero meditante”, più profondo e originario, che si interroga sul senso dell’essere e sul destino dell’uomo.
- Gelassenheit: La “serenità” o “abbandono”, l’atteggiamento che permette di usare la tecnica senza esserne dominati.
Riferimenti bibliografici
- Heidegger, M. (1927). Essere e Tempo (Sein und Zeit).
- Heidegger, M. (1953). La questione della tecnica (Die Frage nach der Technik), in Saggi e discorsi.
- Heidegger, M. (1955). “Gelassenheit”.