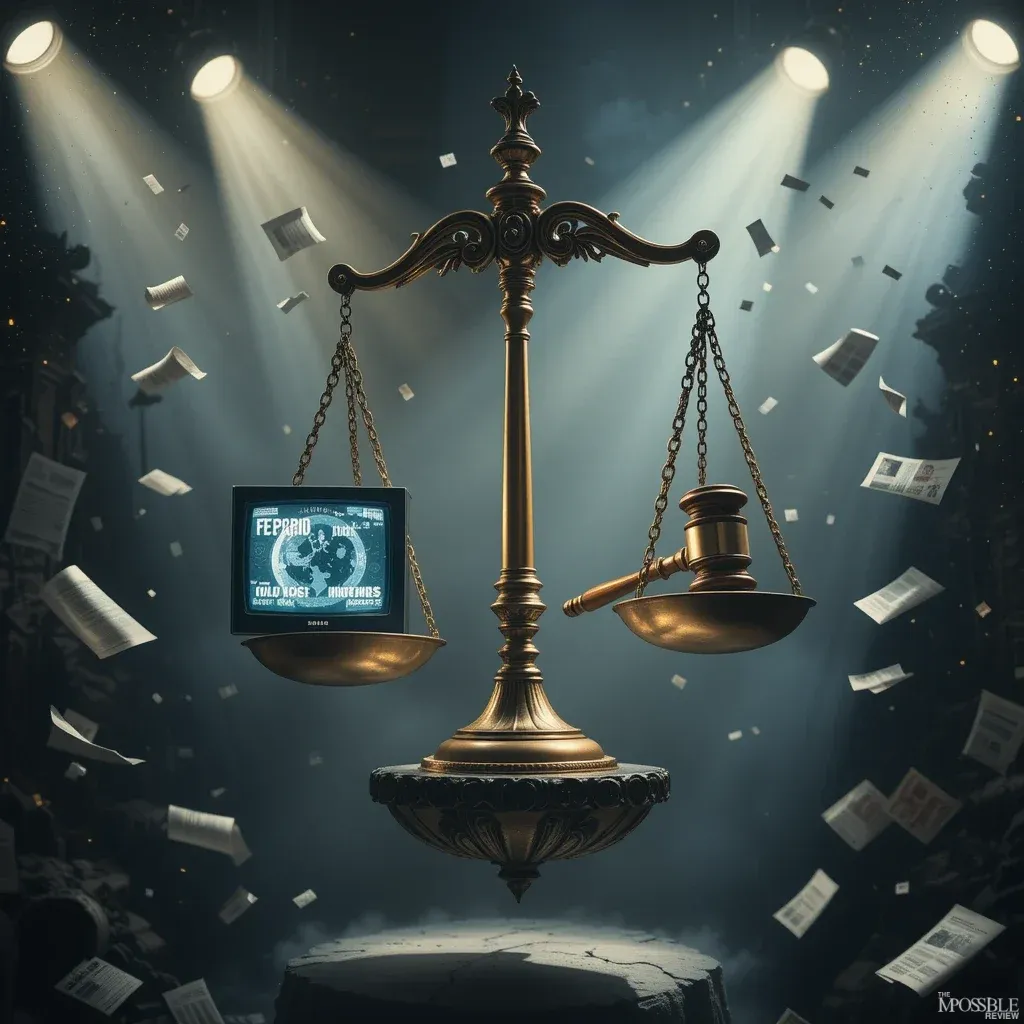Come riportato da AGI, la recente sentenza della corte suprema britannica ha stabilito che nell’ambito della legge sulle pari opportunità del 2010 la parola “donna” si riferisce solo alle persone dichiarate di sesso femminile alla nascita. Questa decisione, scaturita da un ricorso dell’associazione femminista For Women Scotland, ha riacceso il dibattito sui diritti delle persone transgender nel Regno Unito.
Abbiamo chiesto a Simone de Beauvoir, filosofa esistenzialista e autrice del celebre saggio “Il secondo sesso” (1949), di condividere la sua visione su questa controversa sentenza. La sua pionieristica analisi sulla costruzione sociale del genere e sulla condizione femminile la rende una voce particolarmente pertinente per esaminare le attuali tensioni tra femminismo tradizionale e diritti transgender, offrendo una prospettiva che può illuminare le complesse questioni di identità, corpo e autodeterminazione che sono al centro di questo dibattito contemporaneo.
Madame de Beauvoir, cosa pensa della recente sentenza della corte suprema britannica che esclude le donne transgender dalla definizione legale di “donna”?
Questa sentenza rivela una contraddizione fondamentale nel modo in cui concepiamo il genere nella nostra società. Quando ho scritto che “non si nasce donna, lo si diventa”, intendevo sottolineare che la femminilità non è una qualità biologica innata, ma una condizione costruita dalla società. La femminilità è un apprendistato, un divenire. Il corpo biologico è certamente una realtà, ma il significato che gli attribuiamo è una costruzione culturale. Trovo profondamente problematico che un tribunale pretenda di fissare in modo definitivo ciò che è fluido e costruito socialmente.
Nel “Secondo sesso” lei ha sviluppato i concetti di trascendenza e immanenza, sostenendo che le donne sono spesso confinate nell’immanenza mentre gli uomini possono aspirare alla trascendenza. Come leggerebbe la lotta delle persone transgender alla luce di questa dicotomia filosofica?
Nella mia opera ho sostenuto che la condizione femminile è stata storicamente caratterizzata da una condanna all’immanenza – la ripetizione ciclica, il mantenimento della vita, l’essere confinata in un ruolo definito da altri. La trascendenza – la capacità di progettarsi verso il futuro, di creare, di trasformare il mondo – è stata invece tradizionalmente riservata agli uomini.
Ciò che trovo interessante nella condizione transgender è precisamente un atto radicale di trascendenza. Rifiutare la definizione imposta alla nascita rappresenta un gesto esistenziale di auto-creazione, un rifiuto dell’immanenza forzata. È un’affermazione potente che l’essere umano non è riducibile alla sua fattualità biologica.
Allo stesso tempo, vedo una tragica ironia nella società contemporanea che, pur disponendo di mezzi scientifici e concettuali per superare le limitazioni biologiche, continua a imporre categorie rigide che confinano le persone nell’immanenza. La vera libertà consisterebbe nel riconoscere che ogni essere umano deve poter esercitare la propria trascendenza, definendo il proprio progetto esistenziale al di là delle determinazioni biologiche o sociali precostituite. Il corpo non dovrebbe essere una prigione, ma un punto di partenza per la libertà.
Può spiegarci meglio questo concetto?
La fenomenologia ci insegna che il corpo non è semplicemente un oggetto esterno che possediamo, ma è la nostra modalità primaria di essere nel mondo. È attraverso il corpo che percepiamo, agiamo e siamo percepiti. Quando nei miei scritti parlavo del “corpo vissuto”, intendevo questa dimensione soggettiva e intersoggettiva dell’esperienza corporea.
L’esperienza transgender mi sembra rivelare con particolare acutezza questa distinzione tra il corpo come oggetto biologico e il corpo vissuto. Per una persona transgender, esiste una dissonanza radicale tra il corpo come fatto biologico oggettivo e il corpo come esperienza vissuta soggettivamente. Questa dissonanza non è un capriccio o un’illusione, ma una realtà esistenziale profonda.
La società tende a privilegiare una visione oggettivante del corpo, riducendolo alla sua materialità biologica. Ma dal punto di vista fenomenologico, il corpo vissuto ha una verità esistenziale non meno autentica del corpo biologico. Modificare il proprio corpo per allinearlo con la propria esperienza vissuta non è un atto di negazione della realtà, ma un tentativo di risolvere una contraddizione esistenziale profonda.
E con “il corpo è una situazione”, intendevo che è il contesto concreto all’interno del quale esercitiamo la nostra libertà. Per le persone transgender, questa situazione è particolarmente complessa e spesso dolorosa. La loro lotta per trasformare questa situazione è un atto esistenziale di autenticità che merita rispetto e riconoscimento.
Molti citano la sua famosa frase “Non si nasce donna, lo si diventa” per sostenere i diritti transgender. È corretto utilizzare il suo pensiero in questo modo?
Non possiamo ignorare che quella frase è stata scritta in un contesto storico e teorico specifico. Tuttavia, ritengo che l’intuizione fondamentale – ovvero che il genere è una costruzione sociale che trascende la biologia – rimane valida e può certamente illuminare la condizione transgender.
Se “diventare donna” significa assumere un ruolo sociale, affrontare la propria situazione nel mondo e trovare la propria autenticità all’interno di strutture oppressive, allora le donne transgender certamente “diventano donne” in questo senso esistenziale. La loro lotta per l’autodeterminazione contro un ordine sociale che cerca di negare la loro identità è profondamente coerente con la mia visione dell’autenticità e della libertà.
J.K. Rowling, autrice di “Harry Potter”, ha elogiato la decisione della Corte Suprema britannica affermando che “protegge i diritti di donne e ragazze in tutto il Regno Unito”. Cosa pensa al riguardo?
Trovo nella posizione di J.K. Rowling e di altre intellettuali simili ciò che ho definito “malafede esistenziale” nei miei scritti filosofici. La malafede è una forma di auto-inganno in cui si nega la propria libertà rifugiandosi in ruoli e categorie predefinite per evitare l’angoscia della responsabilità esistenziale.
Quando una scrittrice come Rowling insiste sulla biologia come criterio definitivo dell’essere donna, vedo una doppia malafede: da un lato nega la propria libertà creativa come intellettuale, rifugiandosi in una definizione che appare come “naturale” e quindi inevitabile; dall’altro nega ad altre persone la possibilità di autodefinirsi, imponendo categorie che pretendono di essere oggettive ma sono profondamente politiche.
Ciò che mi colpisce è anche la contraddizione performativa in questa posizione: scrittrici che hanno usato la loro immaginazione creativa per costruire mondi fantastici sono poi incapaci di immaginare forme di esistenza che sfidano le categorie convenzionali. La creatività letteraria e la rigidità del categorizzare sembrano curiosamente coesistere.
Vedere oggi alcune femministe alleate con forze conservatrici per limitare la libertà di autodefinizione di altri esseri umani rappresenta una profonda ironia storica. Il femminismo o è un umanesimo radicale che lotta per la libertà di tutti gli esseri umani, o tradisce la sua stessa ragion d’essere.
Nel suo saggio “Per una morale dell’ambiguità”, lei sostiene che l’esistenza umana è fondamentalmente ambigua e che un’etica autentica deve abbracciare questa ambiguità piuttosto che negarla. Questa prospettiva può illuminare il dibattito contemporaneo?
Sì, ho sostenuto che la condizione umana è fondamentalmente ambigua: siamo esseri finiti con desideri infiniti, soggetti ma anche oggetti, libertà situate in un mondo di necessità. Un’etica autentica deve riconoscere questa ambiguità invece di negarla attraverso dogmi assoluti o riduzioni semplicistiche.
Il dibattito contemporaneo sui diritti transgender e le tensioni nel movimento femminista rivelano proprio questa difficoltà di fronte all’ambiguità. Da un lato vediamo chi cerca certezze assolute nella biologia, dall’altro chi vorrebbe dissolvere completamente ogni determinazione materiale in favore della pura auto-definizione.
Un’etica dell’ambiguità ci inviterebbe a rifiutare entrambi questi estremi. Non possiamo ignorare la realtà materiale dei corpi e delle storie diverse, ma non possiamo nemmeno ridurre l’esistenza umana a queste determinazioni. L’identità di genere emerge proprio in questo spazio ambiguo tra dato e costruito, tra necessità e libertà.
Le femministe che si oppongono all’inclusione delle donne transgender cercano una certezza in un mondo di ambiguità. Ma questo desiderio di certezza è proprio ciò che ho sempre criticato come una fuga dalla responsabilità etica. Accettare l’ambiguità significa accettare che le categorie umane non sono mai definitive, che i confini sono sempre porosi, che la nostra comprensione dell’esperienza umana è sempre in divenire.
Un movimento femminista fedele a un’etica dell’ambiguità dovrebbe riconoscere la molteplicità delle esperienze femminili senza cercare di imporre una definizione univoca di “donna”. Dovrebbe lottare contro tutte le forme di oppressione senza crearne di nuove. Solo attraverso questo difficile esercizio di libertà situata e di solidarietà nella differenza possiamo sperare di costruire un mondo più giusto per tutti gli esseri umani nella loro meravigliosa e irreducibile diversità.
Come vede il futuro di questo dibattito?
La storia del pensiero umano è sempre stata una dialettica tra inclusione ed esclusione, tra apertura e chiusura. Nel lungo periodo, credo che prevaleranno le forze dell’inclusione e del riconoscimento reciproco, perché sono più consonanti con la nostra aspirazione alla libertà e all’autenticità.
Il femminismo che ho contribuito a fondare non aveva come obiettivo la creazione di nuovi recinti e nuove esclusioni, ma l’abolizione di tutte le strutture che impediscono agli esseri umani di realizzare pienamente la propria libertà. In questo senso, la causa transgender e la causa femminista sono profondamente alleate in una lotta comune per un mondo più giusto e più libero.
Glossario
- Esistenzialismo: Corrente filosofica che pone l’accento sulla libertà e responsabilità individuale, sull’importanza delle scelte personali e sull’autenticità. De Beauvoir ne fu una delle principali esponenti.
- Essenzialismo: Posizione filosofica che sostiene l’esistenza di caratteristiche innate, necessarie e immutabili che definiscono un’entità. Nel dibattito di genere, si riferisce alla credenza che esistano qualità femminili e maschili innate e predeterminate.
- Situazione: Concetto chiave nell’esistenzialismo di de Beauvoir che descrive il contesto concreto (sociale, storico, corporeo) all’interno del quale l’individuo esercita la propria libertà.
Riferimenti bibliografici
- de Beauvoir, S. (1949). Il secondo sesso. Gallimard, Parigi.
- de Beauvoir, S. (1947). Per una morale dell’ambiguità. Gallimard, Parigi.