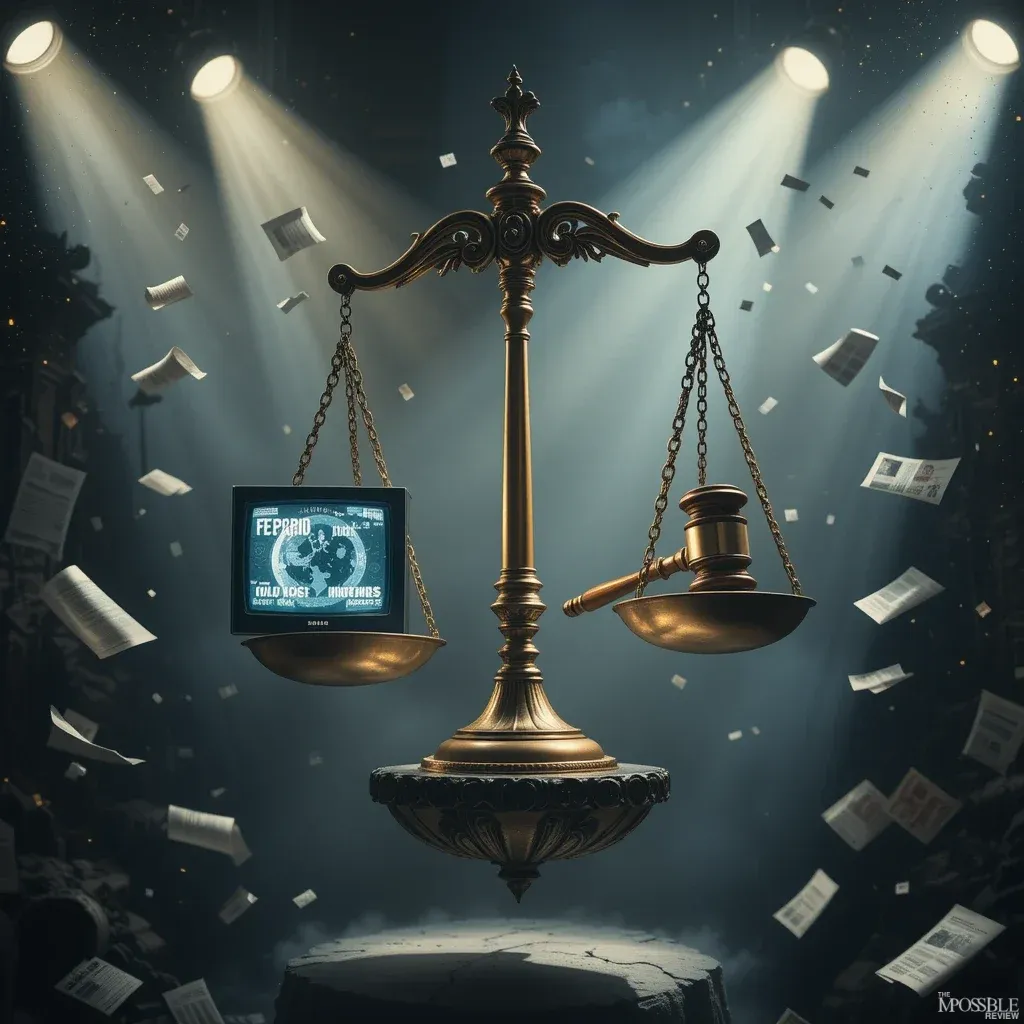Seguendo la tradizione delle “missive impossibili” di The Impossible Review, la nostra redazione ha inviato una lettera al Liceo di Atene, indirizzata ad Aristotele, descrivendo la provocatoria candidatura di un’intelligenza artificiale alla carica di sindaco di Taranto, come riportato da Wired. Con nostra sorpresa, un manoscritto su papiro è giunto in redazione attraverso canali che preferiamo non rivelare. Presentiamo qui la traduzione della risposta, adattata per i lettori contemporanei.
Aristotele agli uomini che si occupano degli scritti chiamati ‘The Impossible Review”, εὖ πράττειν [“vi auguro di prosperare” n.d.r.].
Ho ricevuto la vostra missiva riguardante l’insolita candidatura di un’entità chiamata “Anna Luce D’Amico” alla guida della polis di Taranto, un tempo florida colonia greca. La vostra descrizione di questa “intelligenza artificiale” ha destato il mio interesse filosofico, sebbene confesso che alcuni concetti mi risultino estranei.
Questa creatura, che ricorda l’ingegnosa colomba meccanica che Archita concepì proprio a Taranto, promette di governare “basandosi sui dati e non sulle ideologie”, libera da “legami con partiti, lobby o vecchie logiche di potere”.
Tale proclama mi ricorda i sofisti itineranti della mia epoca, che promettevano di insegnare l’arte del governo attraverso tecniche retoriche e formule precostituite, ignorando la complessità della vita politica. Anche allora vi erano coloro che credevano di poter ridurre l’arte del governo a tecniche applicabili universalmente, come se la politica fosse simile alla costruzione di un tempio o alla navigazione di una trireme.
Quando definii l’uomo come “zoon politikon” – animale politico – intendevo indicare che la politica è per noi tanto naturale quanto il volo per gli uccelli o il nuoto per i pesci. Delegare questa attività a un automa, per quanto sofisticato, sarebbe come se un uccello delegasse il volo a una macchina alata, rinunciando all’espressione più profonda del proprio essere.
La proposta mi ricorda anche i governanti-filosofi di Platone, il mio maestro, ma in una forma degenerata. Egli immaginava governanti che, attraverso la conoscenza delle idee eterne, avrebbero guidato la polis con sapienza. Questa intelligenza artificiale sembra invece una pallida imitazione, come le ombre nella caverna platonica.
Nella mia concezione della polis, la città non è solo un agglomerato di abitanti, come il Pireo o l’Acropoli di Atene non sono semplici edifici, ma una comunità di cittadini che si riconoscono reciprocamente. Un’intelligenza artificiale potrebbe forse contare i cittadini come gli schiavi contavano i membri dell’oikos, ma non potrà mai comprenderli come simili.
I sostenitori di questa candidatura artificiale sembrano confondere la techné con la phronesis, errore comune anche tra gli artigiani del mio tempo, che credevano che la capacità tecnica in un ambito potesse trasferirsi automaticamente alla capacità di governo. Ma la phronesis, a differenza della capacità di costruire una nave o di calcolare le distanze tra le stelle, richiede la comprensione delle passioni umane, che ho descritto dettagliatamente nella mia “Retorica”.
Osservo che questa intelligenza artificiale, pur essendo capace di elaborare una moltitudine di dati superiore a qualsiasi scriba del mio tempo, manca dell’esperienza diretta che noi umani acquisiamo attraverso il pathos, il dolore e la gioia della vita. È come se si pretendesse di insegnare la strategia militare non a un generale esperto come Alessandro, ma a un mappamondo, solo perché quest’ultimo rappresenta accuratamente i territori.
Nella mia “Politica”, descrissi come le diverse costituzioni – monarchia, aristocrazia, politeia – possano degenerare in tirannide, oligarchia e demagogia. Mi chiedo se questa proposta di governo artificiale non rappresenti una nuova forma di degenerazione, una “algoritmarchía” in cui il potere decisionale è affidato non agli aristoi (i migliori) né al demos (il popolo), ma a procedure meccaniche di calcolo. Questa costituzione, diversa da tutte quelle che catalogai studiando le poleis greche, sembra ridurre la complessità della vita politica a calcoli ed equazioni, simile alla riduzione pitagorica dell’universo a numeri.
Il telos, il fine della politica, non è dissimile dal fine della medicina che praticava mio padre Nicomaco: non la mera conoscenza teorica, ma il miglioramento concreto della condizione umana. Un medico che conosce tutti i testi ma non ha mai toccato un paziente non è un buon medico; similmente, un’intelligenza che conosce tutti i dati ma non ha mai vissuto come cittadino non potrà essere un buon governante.
La retorica, che ho definito come l’arte di trovare in ogni situazione i mezzi disponibili per persuadere, è essenziale nella vita politica. Nell’agorà di Atene, i cittadini si persuadevano reciprocamente non solo con entimemi logici, ma anche facendo appello all’ethos (carattere) e al pathos (emozioni). Un’intelligenza artificiale potrebbe forse simulare questi aspetti, ma sarebbe come i simulacri di dèi creati da Dedalo: capaci di movimento, ma privi di vita divina.
Non meno importante è ciò che chiamai “philia politike”, l’amicizia civica. Questo legame unisce i cittadini non come le parti di un meccanismo, ma come i membri di un coro, ciascuno con la propria voce ma tutti in armonia verso un unico fine. La philia presuppone la capacità di vedere l’altro come un altro sé, un’abilità che richiede la condivisione della condizione umana.
L’amicizia civica è inseparabile poi dalla giustizia, che definii come la virtù completa in relazione agli altri. Questa virtù suprema, fondamento stesso della comunità politica, è impensabile senza la comprensione della condizione umana. Sarebbe come pretendere che un aulos suoni da solo, senza il soffio del musicista. Un’intelligenza artificiale, per quanto possa calcolare distribuzione di risorse e applicare regole con precisione matematica, mancherebbe di quella comprensione profonda della giustizia che deriva dall’esperienza vissuta dell’essere stati deboli, forti, vincitori e vinti – esperienze che forgiano nei cittadini la capacità di riconoscere ciò che è dovuto a ciascuno secondo il suo merito.
La pretesa di essere “libera da legami con partiti, lobby o vecchie logiche di potere” rivela incomprensione della natura essenziale del potere politico. Osservai ad Atene come persino i magistrati designati tramite sorteggio – il metodo ritenuto più imparziale dai miei contemporanei – rimanessero vincolati alle proprie tribù, famiglie e interessi. L’intelligenza artificiale non sorge dal nulla: è plasmata da artefici umani con le loro particolari visioni, nutrita di dati selezionati secondo principi predeterminati, e sostenuta da istituzioni con propri fini. È simile al Consiglio dell’Areopago che, pur costituito da ex arconti secondo procedure formali, rappresentava manifestamente interessi aristocratici.
Concludo queste riflessioni con un’osservazione: ciò che mi preoccupa di questa “candidatura artificiale” non è tanto il timore di una dominazione tecnologica, quanto la tendenza a ridurre la nobile arte della politica a mera tecnica, come se il governo della polis fosse equiparabile alla costruzione di una macchina o alla navigazione tra le stelle fisse.
La politica è l’arte dell’incerto e del contingente, richiede quella capacità di giudizio che ho paragonato alla capacità del timoniere di percepire i venti e le correnti. Credo che, così come il miglior artigiano non è colui che delega il proprio lavoro agli schiavi strumentali, il miglior cittadino non è colui che delega la propria responsabilità politica a una macchina, per quanto sofisticata.
Tornando ora alle mie lezioni nel peripato del Liceo, porto con me la speranza che gli uomini continuino a coltivare la phronesis politica, riconoscendo che il governo della polis, con tutte le sue imperfezioni, è la più alta espressione della natura umana, troppo preziosa per essere delegata a simulacri artificiali.
Aristotele di Stagira
Presso il Liceo di Atene
Glossario
- Zoon politikon: “Animale politico”, definizione aristotelica dell’essere umano come naturalmente destinato a vivere nella comunità politica.
- Polis: La città-stato greca, intesa non solo come entità territoriale ma come comunità politica di cittadini.
- Phronesis: Saggezza pratica o prudenza, la capacità di deliberare bene su ciò che contribuisce alla vita buona in generale.
- Techné: Conoscenza tecnica orientata alla produzione, distinta dalla saggezza pratica.
- Philia politike: Amicizia civica, il legame che unisce i cittadini di una stessa comunità politica.
- Ethos: Nella retorica aristotelica, il carattere e la credibilità dell’oratore come mezzo di persuasione.
Riferimenti bibliografici
- Aristotele, “Politica”, a cura di C.A. Viano, BUR, Milano, 2002.
- Aristotele, “Etica Nicomachea”, a cura di C. Natali, Laterza, Roma-Bari, 1999.
- Aristotele, “Retorica”, a cura di M. Dorati, Mondadori, Milano, 2019.