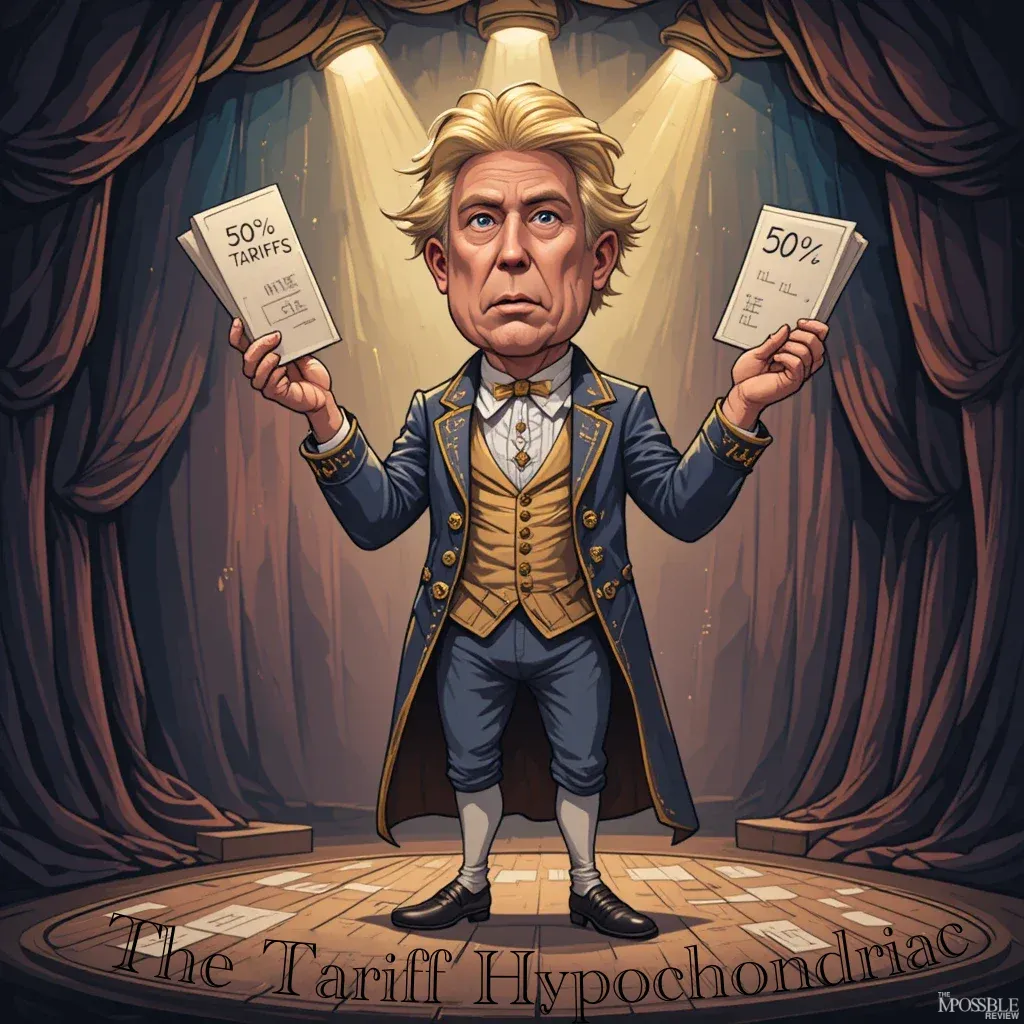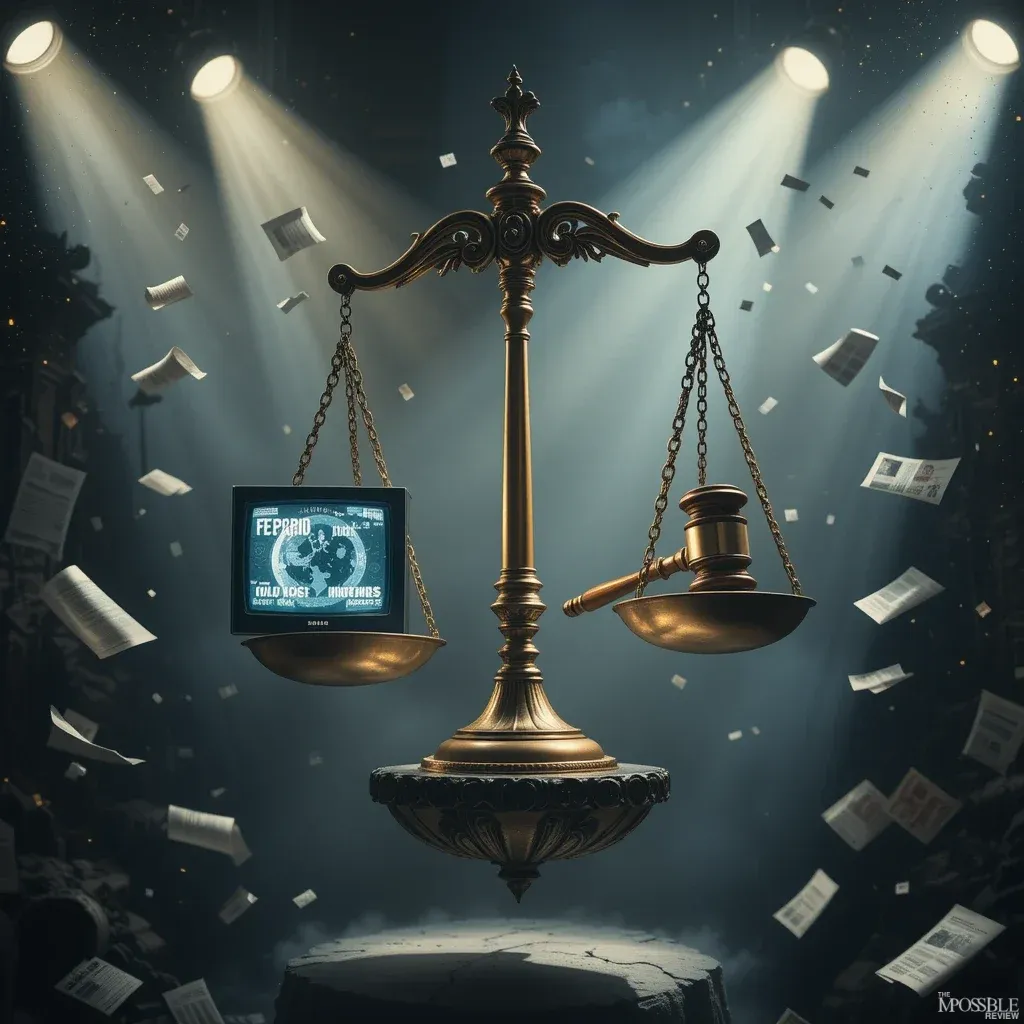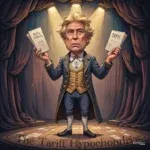Il tema proposto pone un’importante riflessione sulla disparità di attenzione tra le preoccupazioni economiche immediate, come i dazi commerciali statunitensi annunciati il 2 aprile (il cosiddetto “Liberation Day”), e le conseguenze a lungo termine della crisi climatica sull’economia globale. Uno studio australiano rivela che i modelli attuali potrebbero aver gravemente sottostimato l’impatto economico del cambiamento climatico, con previsioni di un possibile calo del PIL globale fino al 40% entro il 2100 in uno scenario di riscaldamento di quattro gradi.
Ci siamo dunque attivati per un’intervista impossibile, per chiedere a Rachel Carson (1907 – 1964), biologa marina e scrittrice il cui libro “Primavera silenziosa” ha catalizzato il moderno movimento ambientalista, di condividere la sua visione su questa disparità di attenzione. La sua pionieristica denuncia degli effetti dei pesticidi sugli ecosistemi e la sua capacità di comunicare complesse questioni scientifiche al pubblico generale la rendono una voce ideale per analizzare come la società contemporanea stia sottovalutando le minacce esistenziali a favore di preoccupazioni economiche immediate.
Signora Carson, lei ha cambiato il modo in cui guardiamo all’impatto umano sull’ambiente. Oggi assistiamo a una grande preoccupazione per l’impatto economico dei dazi commerciali, mentre gli effetti del cambiamento climatico sul PIL vengono largamente ignorati. Come interpreta questa disparità?
Questa disparità riflette una caratteristica profondamente radicata nell’umanità moderna: la miopia temporale. Gli esseri umani tendono a rispondere con urgenza a minacce immediate e tangibili, mentre sottovalutano sistematicamente pericoli graduali ma potenzialmente catastrofici. I dazi commerciali rappresentano un evento economico circoscritto con conseguenze visibili nel breve termine – una riduzione del PIL dello 0,2% per gli Stati Uniti o dello 0,4% per l’Europa. La crisi climatica, invece, si sviluppa lentamente, ma i suoi effetti cumulativi potrebbero portare a un calo del PIL globale fino al 40%, ben 100 volte le stime odierne, entro la fine del secolo. È come se stessimo discutendo animatamente di un graffio sul braccio mentre ignoriamo una malattia sistemica che sta silenziosamente compromettendo i nostri organi vitali.
Un recente studio australiano suggerisce che i modelli economici attuali sottovalutano drasticamente l’impatto economico del cambiamento climatico, perché tendono a considerare solo gli effetti del mutare delle condizioni climatiche a livello locale. Lei ha sempre enfatizzato l’interconnessione degli ecosistemi. Vede paralleli con l’interdipendenza delle economie globali?
Assolutamente. Quando scrissi “Primavera silenziosa”, illustrai come i pesticidi non rimanessero confinati ai campi agricoli ma percorressero catene ecologiche complesse, contaminando acque, suoli e organismi apparentemente distanti. Oggi, l’economia globale funziona in modo simile. I modelli economici tradizionali commettono lo stesso errore che fecero gli entusiasti dei pesticidi negli anni ’50: considerare i sistemi come compartimenti stagni piuttosto che come reti interconnesse. Quando un raccolto fallisce in India a causa della siccità, questo non è un problema isolato “indiano” ma si ripercuote sulle catene di approvvigionamento globali. Quando eventi meteorologici estremi colpiscono regioni chiave della produzione, gli effetti si propagano come onde attraverso l’economia mondiale. L’interdipendenza che osserviamo in natura si riflette nelle nostre strutture economiche, eppure continuiamo a utilizzare modelli che frammentano artificialmente questa realtà.
Nella sua opera, lei ha saputo comunicare concetti scientifici complessi rendendoli accessibili al pubblico. Come dovremmo comunicare le implicazioni economiche del cambiamento climatico per superare questa apparente indifferenza?
La scienza economica, come l’ecologia, può sembrare astratta fino a quando non la colleghiamo alle esperienze umane quotidiane. Dobbiamo tradurre quel calo del 40% del PIL in storie concrete: cosa significa per la disponibilità di cibo, per il costo della vita, per la stabilità sociale. In “Primavera silenziosa”, non parlai semplicemente di bioaccumulo o processi biochimici; dipinsi l’immagine di una primavera senza canto di uccelli. Similmente, dobbiamo aiutare le persone a visualizzare non solo il grafico discendente del PIL, ma le città costiere sommerse, i raccolti falliti, le infrastrutture collassate, i conflitti per risorse scarse. L’economia non è un’astrazione – è il modo in cui alimentiamo le nostre famiglie, costruiamo le nostre case, pianifichiamo i nostri futuri. Dobbiamo rendere tangibili queste connessioni, proprio come cercai di rendere tangibile il pericolo invisibile dei pesticidi.
Nella sua opera principale lei ha affrontato la potente industria chimica. Oggi quali forze economiche e politiche ritiene stiano ostacolando una seria considerazione degli impatti economici del cambiamento climatico?
Le dinamiche di potere sono sorprendentemente simili. Negli anni ’60, l’industria chimica attaccò il mio lavoro definendomi “isterica” e “non scientifica”, nonostante la solidità dei dati che presentavo. Oggi, potenti interessi legati ai combustibili fossili continuano a seminare dubbi sulla scienza climatica e a minimizzare le previsioni economiche. Ma c’è una differenza fondamentale: allora, l’industria chimica stava proteggendo principalmente i propri profitti immediati. Oggi, il sistema economico globale è strutturalmente dipendente da pratiche insostenibili. Non si tratta solo di singole aziende che difendono i propri interessi, ma di un intero paradigma economico basato sulla crescita infinita in un pianeta finito. È come se avessimo costruito la nostra casa economica su un terreno che sappiamo essere instabile, ma continuiamo ad aggiungere piani anziché rafforzare le fondamenta. Finché la nostra misura di successo sarà la crescita trimestrale del PIL piuttosto che la sostenibilità a lungo termine, continueremo a sacrificare il futuro per il presente.
Lei ha sempre sostenuto che esistono alternative più sicure alle pratiche dannose. Come possiamo conciliare crescita economica e sostenibilità ambientale?
Non ho mai sostenuto l’abbandono dello sviluppo economico, ma piuttosto un approccio più saggio e lungimirante. Nel mio studio degli oceani, ho imparato come l’apparente immensità del mare nasconda in realtà un ecosistema fragile e finito. Lo stesso vale per la nostra economia: ciò che sembra un sistema infinitamente espandibile è in realtà limitato dalle risorse fisiche di un pianeta che non cresce. Quando criticai il DDT e altri pesticidi, proposi alternative come il controllo biologico degli insetti. Similmente, non dobbiamo scegliere tra prosperità economica e salute ambientale – dobbiamo ridefinire cosa intendiamo per prosperità. Un’economia veramente prospera deve essere resiliente agli shock climatici, deve valutare correttamente i servizi ecosistemici, deve internalizzare i costi ambientali. Quello che lo studio australiano evidenzia è che l’attuale definizione di “ottimale” nei modelli economici è profondamente difettosa – un riscaldamento di 2,7 gradi sarebbe catastrofico per l’economia reale, non solo per gli ecosistemi. La vera innovazione economica del nostro tempo non consiste nell’inventare nuovi strumenti finanziari, ma nel creare sistemi economici che prosperino entro i limiti planetari. La natura non è un settore dell’economia; l’economia è un sottoinsieme della natura.
Se dovesse lasciare un messaggio per le generazioni future che affronteranno le conseguenze delle nostre decisioni attuali, quale sarebbe?
Direi loro ciò che scrissi nelle ultime pagine di “Primavera silenziosa”: “La scelta, dopotutto, è nostra”. Il futuro non è predeterminato da modelli economici o proiezioni climatiche, ma dalle scelte che facciamo oggi. Vorrei che le generazioni future sapessero che avevamo gli strumenti per comprendere le conseguenze delle nostre azioni, che potevamo vedere oltre le preoccupazioni economiche immediate, che potevamo scegliere un percorso di umiltà ecologica e lungimiranza economica. La mia speranza è che nel leggere della nostra epoca, non si imbattano nella storia di un’opportunità mancata, ma nel momento in cui l’umanità finalmente riconobbe che l’economia senza ecologia è come una nave senza bussola – potrebbe navigare velocemente, ma raramente nella direzione giusta. Il vero benessere economico e il benessere ecologico non sono obiettivi in competizione, ma aspirazioni inseparabili per un futuro veramente prospero.
Glossario
- Miopia temporale: Tendenza cognitiva a dare maggior peso agli eventi vicini nel tempo rispetto a quelli distanti, anche quando questi ultimi potrebbero avere conseguenze più significative.
- Servizi ecosistemici: Benefici che le persone ottengono dagli ecosistemi, come acqua pulita, impollinazione delle colture, regolazione del clima, ecc., spesso non adeguatamente valutati nei modelli economici tradizionali.
- Internalizzazione dei costi ambientali: Processo attraverso cui i costi ambientali delle attività economiche, tradizionalmente considerati esternalità, vengono incorporati nei prezzi di mercato.
- Bioaccumulo: Processo attraverso cui sostanze tossiche si accumulano negli organismi viventi, aumentando di concentrazione attraverso la catena alimentare.
Riferimenti Bibliografici
- Carson, R. (1962). Silent Spring. Houghton Mifflin.
- Lytle, M.H. (2007). The Gentle Subversive: Rachel Carson, Silent Spring, and the Rise of the Environmental Movement. Oxford University Press.
- T. Neal, B. R Newell, A. Pitman, Environmental Research Letters (2025). Reconsidering the macroeconomic damage of severe warming